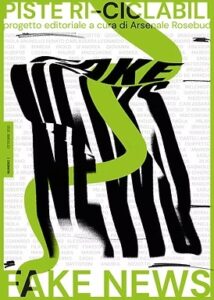
Fake news
L’eco delle false notizie
di Alessandro Civiero
Umberto Eco è stato il più autorevole e insigne dotto della cultura italiana, ordinario di semiotica all’Università di Bologna per molti anni, e studioso della filosofia del linguaggio. Un esperto di simboli e significati. Lo stesso “mestiere” di Robert Langdon, il protagonista de Il Codice Da Vinci. Ovviamente il grande professore ci ha lasciato un’eredità culturale, letteraria, saggistica, scientifica ed erudita enormemente ed incommensurabilmente più grande del puro e semplice divertissement popolare e commerciale di Dan Brown. Intervistato sul fatto che molti degli argomenti trattati dal professore nelle sue opere (in particolare ne Il Pendolo di Foucault) fossero presenti nel romanzo di Brown, egli disse: (Eco) «Sono stato costretto a leggerlo, perché tutti mi facevano domande in proposito. Le rispondo che Dan Brown è uno dei personaggi del mio romanzo Il pendolo di Foucault, in cui si parla di gente che incomincia a credere nel ciarpame occultista.» (Intervistatore) «Ma sembra che lei stesso sia interessato alla cabala, all’alchimia e ad altre pratiche occulte di cui parla nel suo libro.» (Eco) «No, nel pendolo di Foucault ho rappresentato quel tipo di persone in maniera grottesca. Ecco perché Dan Brown è una delle mie creature.» (intervista di Deborah Solomon, La Repubblica, 25 novembre 2007) Tra le opere accademiche di Eco vanno ricordate: Diario Minimo (che comprende il saggio Fenomenologia di Mike Bongiorno), Apocalittici ed Integrati, La struttura assente (sulla semiotica), Estetica e teoria dell’informazione, Trattato di semiotica generale, Come si fa una tesi di laurea, Lector in fabula (sul ruolo del lettore nell’interpretazione testuale), Kant e l’ornitorinco (saggio di semiotica e filosofia), Dire quasi la stessa cosa (sul problema dei significati e dei contenuti nelle traduzioni letterarie), Vertigine della lista (sul tema della rappresentazione); questo solo per citare una parte striminzita della sua produzione saggistica. Inoltre sono indimenticabili gli sferzanti articoletti che apparivano periodicamente nell’ultima pagina del settimanale L’Espresso, nella rubrica La bustina di minerva, con cui il professore si divertiva a dileggiare, dissertare, dissezionare gli aspetti della vita, i fatti quotidiani e le notizie del momento, sempre con l’accento ironico che lo contraddistingueva. Ma l’opera accademica non è stato il solo lascito di Umberto Eco alla letteratura di questo fortunato (letterariamente parlando) Paese. Nel 1980, Eco si cimentò con la narrativa per la prima volta, pubblicando Il nome della rosa. Tutti conoscono questo romanzo, o almeno ne hanno sentito parlare, fosse anche solo per la trasposizione cinematografica di Jean Jacques Annaud con protagonista Sean Connery. Il romanzo, di solito banalmente attribuito al genere giallo deduttivo, è sicuramente un contenitore di generi che spaziano dal thriller, al romanzo storico, gotico, narrativo, divulgativo, filosofico. Un romanzo con molteplici piani di lettura, tanto da contenere riferimenti più o meno velati, più o meno riconducibili ad altre opere letterarie (spesso note solo all’autore o a pochi altri scienziati), e pertanto costruito con una struttura letteraria simile ad una biblioteca. E la biblioteca, lupus in fabula, è la protagonista inanimata dell’intero romanzo. Una biblioteca che è più simile ad un labirinto fatto per occultare il sapere, piuttosto che per divulgarlo. Una struttura arcana, come arcane sono le vie della mente e dello scibile umano. Per quale motivo tutto questo è creato dai monaci dell’innominata abbazia dispersa da qualche parte della pianura Padana, nella notte dei tempi di un brumoso A.D. 1327? Per nascondere un libro. Un libro proibito, naturalmente. Un libro che parla del riso, della risata, dell’umorismo. Scandalo che assale e tormenta l’austero monaco Jorge da Burgos, ossessionato dal fatto che la burla, il riso, la consapevolezza (contenuti discussi nel trattato di Aristotele), siano capaci di distruggere il principio di autorità, quindi delle istituzioni, per
prima la Chiesa. A cosa conduce tutto questo? Al fatto che l’intero impalcato della formidabile costruzione narrativa de Il nome della rosa poggi sull’accettazione convinta dell’antagonista ad una “fake news”. Il presupposto potere di un semplice trattato su uno degli aspetti della natura umana di cambiare, sconvolgere e distorcere l’ordine costituito. Una balla di proporzioni medievali. Il Pendolo di Foucault, secondo romanzo di Eco dato alle stampe nel 1988, è una complessa fiction che ha come perno narrativo la “teoria del complotto”. Ambientato nell’Italia tra gli anni Settanta e primi anni Ottanta, sullo sfondo della scena editoriale e sociale di quel tempo (contestazione, emancipazione culturale, idealismo politico), il romanzo racconta le vicende di uno studente, poi professionista presso un’agenzia letteraria di proprietà di un certo Garamond (nome di un carattere tipografico!) che per riempire le sue serate non ha niente di meglio da fare che inventarsi, assieme agli amici Belbo e Diotallevi, un misterioso complotto storico che intreccia i Cavalieri Templari, la Massoneria, i Rosacroce, il Priorato di Sion, la Cabala, gli Illuminati, il Nazismo, partendo dal basso medioevo fino a raggiungere i giorni nostri. Il protagonista, Casaubon (nome preso a prestito da un filologo francese naturalizzato britannico che viveva in bilico tra ideale cattolico e protestante…), rilegge la Storia in termini diversi da quelli canonici ed accettati, per rielaborare l’intera vicenda umana sotto un nuovo punto di vista: se tutto fosse accaduto, com’è accaduto, in funzione dell’utopistica e famosa ricerca del Sacro Graal (cioè in funzione della ricerca della Verità)? Un gioco da intellettualoidi che, giunto alle orecchie di persone dagli intenti malvagi e subdoli (il pseudo aristocratico Aglié), si espande e cresce autonomamente, si dirama sottotraccia e si sviluppa in modo autonomo e imprevedibile, fino a sconvolgere l’esistenza degli ignari protagonisti, che si ritroveranno invischiati in una spirale di occulte minacce, velate allusioni, oscure trame, inintelligibili macchinazioni, fino a restarne incredibilmente sopraffatti. Vittime (fino al significato letterale del termine) impotenti di fronte ad un mostro senza volto, né contorni distinti, da loro stessi creato, con il pendolo di Leon Foucault che continua, inesorabile e imperturbabile, ad oscillare dalla volta della cupola del Conservatoire national des arts et métiers di Parigi, a rammentarci che, nonostante tutto, il mondo continua a girare. Il secondo romanzo di Eco è una Storia della Menzogna, quasi una denuncia ante litteram, del guazzabuglio odierno delle “fake news”, proponendole in scala storica e mondiale, piuttosto che nelle piccole facezie relative ai Trump di turno o al gossip squallido e generalista. Indubbiamente gli argomenti trattati nel “Pendolo” sono sofisticati ed eruditi, quasi appannaggio di lettori iniziati, sia nella struttura narrativa, composta in libri che rispecchiano le Sephirot della Cabala ebraica, sia nelle citazioni, spesso così astruse e ricercate da essere sconosciute ai più (testi di Bacone, Andreae, Flamel, Ermete Trismegisto, solo per nominarne alcuni). Il pendolo di Foucault, in definitiva, è un’accusa molto anticipata di quello che la società della verità decostruita, dei complotti veri o presunti, delle notizie false che indorano pillole di verità inaccettabili o improponibili, sia diventata la triste normalità con l’avvento di internet e della globalizzazione. Altro romanzo di Umberto Eco, in successione cronologica (1994), è L’isola del giorno prima, racconto di un naufragio che diventa un’esperienza filosofica e un memoriale della vita e delle vicende passate del protagonista. L’ambientazione è nel XVII secolo, all’epoca delle gradi scoperte geografiche, dove il protagonista dichiara con “impenitente concettosità” di impersonare “l’unico essere della nostra specie ad essere naufragato su una nave deserta”. Da questa nave, sulla quale capita a bordo di una zattera in seguito al rovinoso affondamento del vascello su cui viaggiava, il singolare naufrago, dapprima relegato da un’infezione agli occhi a muoversi solo di notte, poi scopre di vedere a poche braccia di mare alcune isole, per lui però irraggiungibili in quanto egli non è capace di nuotare. Dopo aver scoperto di essere nei pressi dell’antimeridiano di Greenwich (o, per meglio dire, alla linea del cambiamento di data), lo sfortunato comincia a fantasticare sul fatto, evidentemente suggerito da un’errata convinzione o falsa notizia, che le isole che egli scruta dal relitto siano irraggiungibili non solo per la distanza spaziale, ma anche temporale, in quanto esse si trovano letteralmente nel giorno prima. Con Baudolino (2000), il professor Eco ci accompagna in un viaggio attraverso mondi sconosciuti, terre ignote e paesaggi fantastici, assieme ad un giovane villico piemontese, burlone e incallito bugiardo. Baudolino inventa storie improbabili e, in bilico tra fatti e personaggi storici del medioevo europeo e miti orientaleggianti da lui stesso immaginati (ripresi in gran parte dai racconti de “Il Milione” di Marco Polo), che ne influenzano le vicende, resta talmente condizionato dagli uni e dalle altre al punto d’intraprende un epico e picaresco viaggio alla ricerca del mitico reame di Prete Gianni. Amalgamando ingredienti costituiti da documenti e fonti attendibili con leggende e storie strampalate, Baudolino è di fatto un creatore di fake news. Notizie false, episodi storici e spirito burlesco sono gli sproni da cui il protagonista, non un erudito o un saggio, ma un semplice contadino, influenza la propria esistenza e quella degli altri personaggi, fino a costruirsi un destino sconosciuto, avventuroso e ineluttabile che lo porterà a perdersi nell’ignoto di una storia e una geografia del tutto false, nuove, ma non meno affascinanti rispetto alla realtà. La lezione di Eco è probabilmente da condensare nell’assunto di come una storia possa diventare vera semplicemente prendendola e costruendola come tale. Una sorta di denuncia su ciò che Eco pensava del mondo, dove “utopie date per vere servono a sopportare gli inganni della realtà”. La misteriosa fiamma della regina Loana (2004) è il romanzo più autobiografico scritto da Umberto Eco. È la storia di un professore di lettere che, a seguito di un ictus, perde la memoria del suo passato, anche se conserva quella nozionistica e intellettiva. Per recuperare il mondo delle sue esperienze pregresse, spinto dalla moglie, torna nella casa atavica, tra le Langhe ed il Monferrato (le terre di Eco), riscoprendo nella polverosa soffitta gli oggetti materiali della sua infanzia che diventano il mezzo per ricostruire la memoria. I documenti che costituiscono i mattoni della sua vita sono quelli di chiunque altro: vecchi quaderni di scuola, romanzi di formazione, dischi, testi di canzoni, fumetti (“la misteriosa fiamma della regina Loana”) e altri ricordi della giovinezza, di cui l’autore fa un ampio e nostalgico excursus, fino a rimodellare passo dopo passo i ricordi in una dichiarata operazione nostalgica. Parallelamente alla memoria del protagonista, torna a galla ed è descritto il Ventennio fascista, periodo della sua gioventù, e la memoria del personaggio diviene la memoria collettiva e storica, corredata anche da immagini, cartoline e slogan di una propaganda (quella fascista) che ha comunque a che fare con il concetto delle “fake news”. La riscoperta della biblioteca del nonno ed in particolare di un testo cercato per molti anni, fa ripiombare il protagonista da uno stress intellettuale ad un altro ictus, in cui la memoria personale riaffiora nella sua interezza, ma lo condanna al fatto che “nello stesso istante in cui seppe, cessò di sapere.” Gli ultimi due romanzi pubblicati da Umberto Eco sono Il cimitero di Praga e Numero Zero. È in questi due libri che il professore di semiologia, a mio avviso, fa i conti direttamente con il concetto delle “fake news”. Il cimitero di Praga (2010) è un romanzo concepito come un feuilleton ottocentesco dedicato alla figura dei falsari dell’odio e dell’antisemitismo. Il protagonista è infatti un antisemita che fabbrica letteralmente degli pseudo documenti per gettare discredito e accuse infamanti sull’intera comunità ebraica. Questi documenti, storicamente esistenti e circolanti nell’Europa del XIX e XX secolo, in particolare il famoso “protocollo dei Savi di Sion”, sono il centro della vicenda narrata e sono attribuiti al fosco protagonista del romanzo, mentre, in realtà, sarebbero dei falsi storici probabilmente prodotti dall’Ochrana, la polizia segreta zarista, e utilizzati come pretesto per la persecuzione degli ebrei russi. Tornano qui i temi già trattati ne Il Pendolo di Foucault, come la teoria del complotto, le società segrete, la massoneria deviata.
Infatti, i famigerati “protocolli” non sarebbero altro che la prova dell’esistenza di un complotto giudaico per la conquista del mondo. Giustificazione illustrata anche da Herr Hitler nel suo “Mein Kampf” per dar fondamento al suo odio razziale. La storicità della vicenda è sostenuta dal fatto che tutti i personaggi del romanzo sono realmente esistiti, tranne il protagonista, e questo evidenzia con clamore il fatto che le false notizie, le “fake news”, siano state sempre protagoniste ed armi affilatissime con cui la società moderna e contemporanea abbia continuamente avuto a che fare, soprattutto quando hanno trovato e trovano terreno fertile su di cui prosperare. Il romanzo è talmente ben congeniato che i giornali contemporanei, tra i quali l’Osservatore Romano – della serie: chi è senza peccato scagli la prima pietra – e molti intellettuali si sono scandalizzati, criticando con articoli ed interviste la presunta posizione del professor Eco sulla mentalità retrograda di certi ambienti cattolici, sul suo presunto elogio all’antisemitismo contenuto nel romanzo, rimproverando l’accademico di fomentare, attraverso la sua finzione, un cancro sociale mai estirpato. In pratica l’accusa di produrre “fake news”, mentre Eco cercava proprio di mettere in luce il vero problema della moderna comunicazione di massa. L’ultimo romanzo di Umberto Eco, pubblicato nel 2015, si intitola Numero Zero. In editoria, il “numero zero” è la prova generale dell’impostazione grafica e giornalistica di un quotidiano o di una rivista. L’informazione, e soprattutto l’informazione distorta, è la protagonista dell’ultima opera letteraria dell’accademico piemontese. Un editore senza scrupoli, mosso dall’ambizione di entrare in politica e di far parte della cricca che si spartisce il piatto del potere, utilizza il suo nuovo quotidiano, che deve ancora veder la luce, come arma di ricatto e di minaccia, creando una macchina del fango pronta a far fuoco contro chiunque s’interponga alla sua ascesa. L’editore organizza una raffazzonata redazione raccogliendo attorno ad un cinico ed immorale direttore un’accozzaglia di figure giornalistiche fallite: un cronista di poco successo, una studentessa alle prime armi, un redattore di necrologi, un giornalista d’inchiesta che non è mai riuscito ad ottenere lo scoop della vita. Come nel “Pendolo di Foucault”, i protagonisti si troveranno presto invischiati in fatti inspiegabili, che appaiono verosimili, ma che essi stessi contribuiscono ad inventare, finché queste false notizie prendono una loro vita attraverso filtraggi occulti che finiscono per travolgere le esistenze dei protagonisti. Lo sfondo è molto simile all’altro romanzo, ma il periodo storico è successivo. L’azione si svolge nel ’92, nel periodo di Tangentopoli. Qui i temi trattati sono le inveterate vicende dell’Italia post bellica e il caso scatenante è l’investigazione di uno dei protagonisti sul presupposto che Benito Mussolini non sia stato giustiziato a Dongo, ma sia riuscito a sopravvivere e scappare. S’innesca allora una ridda di ipotesi sulle successive vicende italiche; dagli atti terroristici di matrice neofascista, al tentato colpo di stato di Junio Borghese, la P2, la CIA, i servizi deviati e le consuete amenità che ormai tutti noi siamo abituati a sorbire periodicamente. Solo che, stavolta, alcune notizie appaiono fondate perché a confutarle è nientemeno che l’autorevolezza della BBC. La questione allora si fa seria al punto che l’azione di uno scalcinato gruppo di pennivendoli, senza neanche il supporto di una pubblicazione vera e propria, in quanto il giornale non verrà mai pubblicato fin dalle prime intenzioni dell’editore, produce un tragico omicidio. I protagonisti, ovviamente spaventati ed inorriditi, tentano di sottrarsi al rullo compressore che schiaccia qualsia cosa si trovi davanti e che loro stessi avevano innescato, fuggendo pavidamente e cercando di mettersi in salvo. Sembra però che uno di loro, coinvolto sentimentalmente con la giovane donna del gruppo, capisca che sottrarsi al destino sia del tutto inutile e lo ritroviamo passivo, alla fine del racconto, in attesa di un’inevitabile catastrofe che in realtà non arriva mai in quanto l’autore lascia intendere che la vicenda, quella fittizia del romanzo, ma anche quella dei pseudo misteri narrati, sia del tutto in divenire. Un romanzo sul cattivo giornalismo, sulle “fake news”, sulle false piste che pavimentano le strade larghe e illuminate della realtà così come viene propinata dai mass media e dal potere costituito. Un manuale su ciò che si dovrebbe evitare.
In un’intervista rilasciata da Umberto Eco in occasione della presentazione del suo ultimo romanzo, lo studioso dei significati e dei significanti della lingua scritta e parlata, lanciava un monito, o forse solo un consiglio, su come approdare ad uno dei fondamentali diritti dell’uomo, qual è la consapevolezza delle cose. “La conoscenza consiste nel filtraggio delle informazioni”, affermava Eco, aggiungendo però che: “l’informazione può nuocere alla conoscenza perché dice troppe cose.” (programma Rai “Che tempo che fa” dell’11/01/2015). Pertanto è bene approcciare l’informazione con uno spirito critico e cercando da più fonti l’essenzialità del fatto in quanto tale. È determinante imparare a distinguere il vero humus dalla cotica sterile che c’è in superficie. Leggere un buon libro, ad esempio, aiuta il lettore a formare la propria capacità critica e, spesso, a districarsi in un mondo ormai pieno di informazioni e lanci di stampa strepitosi e destabilizzanti che, molte volte, si rivelano false notizie. Quanto sopra illustrato dimostra, credo, quanto il massimo esperto di comunicazione e simbolismo della cultura italiana fosse interessato e allarmato dal fenomeno delle false notizie e della mistificazione. Lo stesso pensatore che, nel suo primo e più famoso romanzo, però, ci lascia in sospeso con le parole più misteriose, più interpretate e più discusse della letteratura del ventesimo secolo. “Lascio questa scrittura, non so per chi, non so più intorno a che cosa: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.” Ovvero, stando ad alcune interpretazioni, dell’esistenza primigenia delle cose (la rosa), alla fine rimane solo il significato del nudo nome con cui l’indichiamo.

