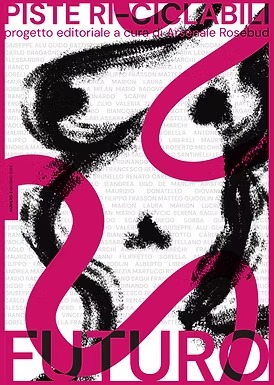
Futuro
La dipendenza affettiva e i suoi paradossi
di Grazia Giacomazzi
Questo testo è stato scritto in occasione della giornata sulla violenza contro le donne tenuto lo scorso 27 novembre a Padova.
Maltrattare una donna è odio irriducibile per la libertà dell’altro. Questo naturalmente non c’entra con l’amore, ma per saperne dell’amore occorre farne esperienza.
L’amore, il legame d’amore, è fondato sul dono e questo si distingue sia dal desiderio, sia dal possesso, vale a dire da quella forma di potere che umilia e mortifica perché vuole l’altro come oggetto di dominio. La violenza ha a che fare con il potere non con l’amore. Perché le relazioni di potere vengano confuse con l’amore ha radici molto profonde. La violenza è un tema che tocca il cuore della civiltà, una civiltà si misura da come viene accolta una donna. Una donna, non una madre, c’è qui una grossa questione: la madre è una figura universale con un suo posto simbolico preciso. Se dico madre tutti noi abbiamo una rappresentazione, la donna invece è una figura della singolarità, la donna in quanto tale è irrappresentabile.
Per questo Lacan diceva “la donna non esiste, esistono le donne”, una per una. La donna è il nome della differenza, della diversità. Il femminile è abitato da questa complessità irriducibile, da una sorta di incongruenza interna, da un salto, pausa, vuoto. Soggettivare la femminilità è un compito molto difficile, complesso, una tensione continua per impedire che quella incongruenza originaria si traduca in vuoto di senso. La donna è lo “straniero” per eccellenza, l’altro nella sua più radicale alterità, non solo per un uomo ma anche per se stessa. Freud, che ha investito l’intera vita nell’interrogarsi tentando di rendere chiaro il non conosciuto che alberga al cuore del soggetto, diceva, a proposito del femminile, il “continente nero” e ammetteva di non essere riuscito a rispondere alla domanda “che cosa vuole una donna?”, non c’è risposta in effetti. In questo senso ogni donna deve inventare la donna. Ma l’invenzione ha necessità di solide premesse familiari e sociali.
Se valutiamo questo aspetto dal versante culturale, possiamo ben dire che la storia non ci ha favorite. La violenza cruenta contro la donna esiste da sempre tant’è che la ritroviamo nei miti, nelle favole: si pensi a quella spaventosa di Barbablù, per non dire dei ratti e degli stupri che ritroviamo nelle cronache antiche. La storia testimonia un dominio del maschile sul femminile rimasto invisibile per secoli. Invisibile perché connotato come “ordine naturale”, vale a dire totalmente determinato, immutabile, universale. In realtà non c’entra nessuna natura, c’entrano le interpretazioni che si danno ai ruoli sessuali per favorire questo o quell’ordinamento sociale.
Il pensiero dominante per secoli e arbitrariamente ha fissato limiti precisi sull’autonomia delle donne, ha favorito il privilegio della posizione maschile e istituito quelle determinanti psicologiche che per secoli hanno spinto le donne a tollerare continue violazioni della loro volontà, libertà e dignità personale. Questo condizionamento sia familiare sia sociale è stato brodo di coltura della posizione della vittima.
A questa altezza la “vittima” poteva trovare il suo riscatto personale e il suo riconoscimento sociale nel passaggio alla madre, unica via d’uscita prevista e legittima per il femminile. Negli anni 70 le donne hanno dato uno scossone a questa storia, uno scossone le cui onde arrivano fino a noi e al tema che stiamo trattando. Il movimento di ridefinizione dei ruoli messo in atto in quegli anni ha aperto una breccia nel muro dell’universale facendone crollare parti consistenti. Nel tentativo di dare a tutti, maschi e femmine, pari opportunità di scelta e di individuazione, quel movimento tuttavia ha mancato l’essenziale. I fatti testimoniano che le conquiste ottenute, e spesso ottenute e articolate con la lente distorta dell’ideologia, non sono state sufficienti e non hanno chiarito la complessità del campo in cui si giocava – e ancora si gioca, talvolta, al massacro – la partita della liberalizzazione dei ruoli sociali dei sessi.
Sia chiaro, rompere quel muro era non solo necessario ma giusto, ma non voglio tacere – anche se qui lo accenno soltanto – almeno due pesanti conseguenze culturali di quel periodo: aver impostato il discorso tendenzialmente sulla “guerra tra sessi” a discapito di un coraggioso confronto; aver confuso la cultura paternalistica (maschilista) con la funzione paterna. L’atto paterno non ha nulla a che fare con la parata fallica o con la padronanza, ha a che fare invece con l’amore. Alla guerra sarebbe preferibile la danza, il gioco, il teatro che rendono vivibile l’inconciliabile; alla confusione tra paternalismo e funzione paterna sarebbe indispensabile poter condividere il compito educativo delle generazioni a venire. Quando si modifica un ordinamento si creano nuovi squilibri che spesso convivono con squilibri precedenti. La realtà si fa molto più complessa, e bisognerebbe riuscire a leggere questa complessità senza stereotiparla, semplificarla. La violenza contro le donne s’inscrive senza dubbio sui resti del crollo della cultura patriarcale – perciò sostenevo all’inizio che è una questione di civiltà – e ha cause molteplici che non si possono approfondire sufficientemente in un solo discorso.
Mi limiterò quindi a tratteggiare i contorni di uno dei possibili fili che esita nella violenza sulle donne. La dipendenza affettiva alla stregua di altre forme di dipendenza patologica ha in sé una contraddizione lacerante e antilibidica, vige sotto l’impero della pulsione di morte, non ha a che fare con l’amore anche se spesso viene confusa con esso, è accompagnata da una lunga militanza di relazioni fondate sulla distruttività e l’autodistruttività. E si manifesta sopratutto in famiglia o comunque nei legami di intimità, nella sfera privata, il che dice anche la difficoltà a distinguere l’amore dalla violenza. L’amore tossico, mortifero, non si fabbrica da sé o esclusivamente attraverso una sequela di cattivi incontri tra uomini e donne. I cattivi incontri iniziano sempre prima. Ogni legame si fonda sulla dipendenza affettiva, noi dipendiamo costitutivamente dall’Altro, in primis dai nostri genitori. Il tipo d’amore che circola in famiglia, per buona parte inconscio, si radica sulla scena inconscia dei bambini, costituendo la radice dell’amore che si vivrà in futuro. Non vorrei essere fraintesa su questo punto perché c’è il rischio di ripristinare un determinismo bieco che nelle vicende umane non è mai possibile.
La questione inconscia impedisce la linearità di causa/effetto e ci rende responsabili anche di quel sapere singolare che non sappiamo di avere, ma di cui siamo ugualmente responsabili. Per questo la psicanalisi ha sempre riconosciuto una forte correlazione tra l’infanzia e i disagi o i disastri della vita adulta. Il legame con il nostro primo altro si costituisce a partire dall’esperienza della presenza e dell’assenza della madre: una scansione fondamentale, anche se dolorosa e frustrante, che apre la strada all’individuazione e al mondo. Il legame è in effetti possibile solo se si è separati, distinti. Troppa presenza è come il sole, non si può guardare il sole, troppa luce acceca e uccide. Così come troppa assenza, che in definitiva è abbandono che offende la vita, non fa sentire al mondo, uccide. L’eccesso di presenza o l’eccesso di assenza uccidono ugualmente la vita e non si tratta solo di morte psichica, a volte di morte anche fisica come capita in tutte le pratiche distruttive e autodistruttive legate alla dipendenza patologica. Tra le molte possibili vi propongo una vignetta. Una vignetta è una descrizione, perciò va letta tenendo presente ciò che la separa da una vicenda reale.
Abbiamo da una parte un dipendente affettivo narcisista maligno che domina e controlla la propria partner, impedisce tutto ciò che può interferire con il proprio benessere – il narcisista è incapace d’amare mentre si aspetta di diritto di essere amato – e non si preoccupa della relazione, almeno fino a quando non si sente minacciato di abbandono, allora cerca ogni mezzo per mantenere il dominio fino ad arrivare alla violenza. Dall’altra abbiamo una dipendente affettiva che soffre di mancanza di autostima, che si assoggetta al partner accettandone gli abusi e anche se non è più innamorata non riesce a lasciarlo perché spaventata dai cambiamenti, animata dalla certezza di non valere, dall’impossibilità di pensarsi sola e di sperare – un giorno – che il suo sacrificio sarà ripagato, almeno fino al momento della ribellione che in questa struttura è in effetti il momento più pericoloso. I manipolatori affettivi, così come i dipendenti affettivi – modalità che spesso coesistono con differenti varianti nella stessa persona – sono abitati da ragioni e sentimenti che difficilmente riconoscono e che per molto tempo sono stati negati e nascosti. Componenti sadiche e componenti masochistiche primitive compongono l’ordito di un tessuto relazionale dove prevalgono cecità e impensabilità.
Dinamiche dove emergono rispecchiamenti narcisistici e idealizzazioni onnipotenti quali potente collante di questi legami tossici. Rimaniamo nella vignetta e proviamo a indagare il fenomeno nel suo aspetto più difficile a dirsi, più subdolo e difficile da riconoscere e che riguarda la vittima. Nelle donne vittime di violenza si rintraccia sempre – quasi sempre (il quasi è legato ad un altro viraggio che dirò tra poco) – una sorta d’incorporazione del fantasma maschile. Le donne si mettono al servizio dei fantasmi dell’uomo. È ciò che si evidenzia con magistrale chiarezza nell’ultimo film della Cortellesi dove il connubio tra coercizione e consenso si fa evidente. Delia è una donna maltrattata, anche se intelligente (ma l’intelligenza non basta ad evitare le botte) e molto generosa (qualità, la generosità, che accompagna spesso il destino di queste donne) vive la sua condizione nella rassegnazione, sorretta da un fantasma sacrificale che rassicura l’uomo violento come se fosse un bambino sfortunato (e molto spesso i maltrattanti lo sono stati bambini sfortunati). È paradossale: qual’è il senso di questo strano fenomeno di comprensione della donna per il suo aguzzino? Perché resta? C’è una forma – paradossale, appunto – di compensazione onnipotente della vittima? Che cosa si aspetta? Tra i fantasmi che agitano l’orizzonte maschile, il fantasma fondamentale iscritto nella cultura, e quindi nell’inconscio, è quello che vuole le donne – non le madri ribadisco, le donne – tutte puttane. È una rappresentazione che ha a che fare con la paura e con il controllo. E’ il modo in cui il maschile tratta l’irrappresentabilità della donna.
A questa altezza l’irriducibilità della donna ad essere iscritta nell’universale (è il lato poco rassicurante della “strega”) si ri-compone e declina su tanti piani: quello dell’immagine della svergognata, della colpevole, del corpo/oggetto da possedere, del corpo/merce che si vende e si compra. Oggetti da capitalizzare come trofei o da rottamare come resti. I fantasmi sono sempre delle semplificazioni della realtà e questi hanno articolazioni differenti nella elaborazione dei traumi che ciascuno di noi incontra a partire da quello iniziale della nascita. Se la sottomissione di Delia rassicura il violento Ivano, inorridisce Marcella, la figlia (che oltretutto rischia la stessa sorte).
C’è un problema di trasmissione che rende particolarmente denso il legame madre – figlia. A prescindere dalla nostra vignetta cinematografica, dove il problema di trasmissione è centrato sul rifiuto della figlia alla rassegnazione della madre (cosa che il film risolve nella più edificante delle possibilità) rimane il tema della difficile soggettivazione singolare, una per una, della posizione femminile. Nessuna madre lo può spiegare, ciascuna deve inventare il suo essere donna, e comunque qualunque risposta resterebbe insufficiente perché la risposta alla domanda “che vuole dire essere una donna?” non si esaurisce sul piano delle significazioni, ma si realizza negli atti i quali, differentemente dalle parole, non sono mai ripetibili. Per la donna la domanda “chi sono?” si pone con insistenza e una delle possibili risposte è: “Sono la tua donna”. Per una donna questa formulazione può essere una declinazione dell’amore che sospende l’irrappresentabilità costitutiva, anche perché, in definitiva, chi ama tende ad appartenersi. Ma è una formulazione che se sostanzia quell’irrappresentabile dandogli statuto di realtà permanente, se si assolutizza nella formula del fare Uno, come si esprime Lacan, il rischio di degradare in violenza è più che probabile.
Bisogna sempre considerare che l’incontro è fatto di due libertà, mai di una sola. Per questo fare Uno oltre che ad essere impossibile se non per qualche miracoloso istante, è pericoloso. Che cos’è la violenza se non spinta all’appropriazione definitiva? Dobbiamo stare tutti –maschi e femmine- molto attenti a dove e come stabiliamo la nostra relazione con l’assoluto. Chi si ama si appartiene, ma si tratta di una appartenenza che ha rinunciato (è una rinuncia attiva non passiva) al possesso altrimenti lo sconfinamento, l’oltraggio ai confini della soggettività, riduce l’altro ad una cosa, ad un oggetto di cui disporre. Questo è uno degli equivoci più frequenti dell’amore quando si danno per scontate cose che scontate non sono. Per questo nella relazione d’amore diventa fondamentale l’articolazione del limite. Ci sono alcuni no che fondano la possibilità del sì, ed è nelle relazioni primarie che avviene il primo incontro d’amore.
Per questo Freud e con lui tutta la psicanalisi, pone l’interdetto edipico, il no che istituisce l’amore nella sua verità, a fondamento del legame sociale. Onorare i confini significa innanzitutto non servirsi dell’altro. Invece nelle storie di soggetti abusanti e abusati – l’abuso ha tante facce non solo quella sessuale – ritroviamo storie di bambini maltrattati ma anche di bambini idealizzati, vale a dire abusati per eccesso di attenzione non solo per difetto di attenzione. Sono due facce della stessa medaglia, fanno parte dello stesso malinteso che confonde l’amore con l’odio, un malinteso che provoca uno smarrimento identitario radicale. Nell’amore va sempre tenuta presente una piccola quota di odio, è la negativizzazione necessaria alle relazioni che si vogliono umane e non ideali. Ma se l’odio viene nascosto dietro la faccia ideale dell’amore, quest’ultimo non è che una forma di idolatria che falsifica completamente l’amore che si vuole mostrare. Essere amati immaginariamente o narcisisticamente vuol dire non essere riconosciuti come soggetti.
Di questa pasta è fatto il nodo del legame tossico, del legame di dipendenza patologica. Allo stesso modo l’amore tra adulti non è un meccanismo automatico che basta innamorarsi perché tutto proceda, l’amore adulto è impegno costante, fatica, che prevede conoscenza e responsabilità. E’ amore del reale, del vero, non dell’ideale. È legame tra singoli che cercano l’altro in quanto singolarità non in quanto idea. Si dice che le donne sono più inclini all’amore, ha una sua verità questa affermazione, mentre, tendenzialmente, gli uomini sono più inclini a farsi amare. Se per loro l’amore è più difficile e costa fatica alfabetizzare gli uomini all’amore (sono ingombrati dalla mascolinità e affascinati dalla moltitudine degli oggetti di desiderio) dobbiamo tuttavia riconoscere che è altrettanto difficile che le donne non confondano il discorso d’amore: di fronte alla difficoltà di soggettivare singolarmente la femminilità, la donna chiede che sia lui, l’uomo, a dare statuto di realtà alla donna.
Dobbiamo dare parola ai mali che ci affliggono, vederli e cercare di capirli. La donna che si assoggetta alla legge del disamore, che subisce la legge perversa del maltrattante, mette in atto una rinuncia. Una rinuncia a riconoscersi un valore intrinseco percependosi come vuoto da riempire o vuoto a perdere: la dipendenza patologica ha questa stretta relazione con il vuoto. Questo fatto è frequente quanto ingiusto, stabilisce uno squilibrio identitario pericoloso. Che ha effetti sulla polis, sul legame sociale sempre più frammentato perché gli individui diventano sempre più incapaci di interiorizzare la complessità della propria esperienza. Sappiamo che a colpire la donna è sempre l’uomo, raramente è la donna che colpisce (nell’anno appena trascorso è successo in quattro casi, poco conosciuti. Quelli di Raffaella Ragnoli e Vita Di Bono che hanno ucciso il marito, e quelli di Alessandra Galea e Valentina Boscaro che hanno ucciso il fidanzato).
La donna culturalmente non può occupare il posto del carnefice di conseguenza queste uccisioni passano inosservate, semmai occupa il luogo della colpa, spesso è ritenuta implicitamente e esplicitamente causa di ciò che l’affligge. Come lo spiegate voi il modo in cui vengono narrati gli stupri? Le molestie? I femminicidi? Perché fin dai tempi di Eva la donna è figura della colpa? La violenza degli uomini è estremamente ripetitiva: la gelosia, prima arrivano le offese, poi lo schiaffo, le minacce, un’escalation che non può essere interpretata come un momento di follia, un raptus. E’ invece un montaggio che si ripete sempre uguale e che le donne – grazie all’informazione a al lavoro dei centri antiviolenza – ora conoscono. Ma l’informazione qui fallisce se non è accompagnata da un percorso formativo che vada all’origine del problema, bisogna considerare le radici inconsce che portano una donna a tollerare così a lungo gli svilimenti, le umiliazioni, le aggressioni. Oltretutto i segni che “qualcosa non va” si colgono anche prima delle condotte esplicite perché questi uomini prima di tutto demoliscono qualsiasi accenno di desiderio, anche il più elementare, poi isolano, manipolano, dominano.
Anche questo è noto, ma la vittima ci casca. Si crede amata, o più precisamente, vuole credere di sentirsi amata. Se è geloso all’inverosimile, se la controlla, la demolisce, la insulta, è perché lui la ama, ci tiene a lei. Guardate che è più frequente di quanto siamo disposti ad immaginare: ci sono donne, soprattutto giovani e giovanissime, che apprezzano questa morbosa attenzione, si sentono appagate. Perché? Perché queste donne resistono all’umiliazione scambiandola per attenzione? Bisogna andare a fondo nelle loro storie. Ma prima di tutto sappiamo essere in atto un tipo di difesa – propria della condizione della dipendenza affettiva – che porta queste donne a non riconoscere o a minimizzare i torti subiti. Scissione, mancato esame con la realtà, minimizzazione, denegazione, mancanza di parole per dire il vissuto, siderazione psichica. Tutte istanze che incontriamo anche nei casi di bambini maltrattati: pur di salvare il legame con figure di riferimento primario sono disposti a tutto, a scindersi e a mettere rigide barriere con l’esterno.
C’è la paura dell’abbandono, la vergogna di non essere o non sentirsi amati, la dolorosa consapevolezza che se si perde il legame primario si cade nell’insignificanza, soprattutto se il mondo ha il volto del giudizio o dell’ostilità e non offre supplenze reali a queste infelici esistenze. Riconoscere qualcuno che ci aggredisce facendoci credere di amarci è molto difficile. La tecnica manipolativa del maltrattante infatti fa vacillare l’integrità mentale della vittima, insinua dubbi sul suo stesso percepito. I violenti solitamente sono uomini di grande abilità che giocano sulla dipendenza affettiva, sul senso di colpa e anche sulla tolleranza e comprensione della vittima: poverino, ha avuto una giornata difficile, una vita difficile. Quante volte ho sentito questa giustificazione! Non esiste nessun poverino, esistono soggetti che devono diventare responsabili delle proprie scelte, di quelle fatte e anche di quelle non fatte e qui il necessario lavoro di consapevolezza riguarda proprio ciascuno/a. Dobbiamo obbligatoriamente passare di qua, trasformare la colpa, il senso di colpa e il conseguente sentimento di riprovazione o di indegnità, in responsabilità.
Per questo non possiamo non considerare la connivenza inconscia che sorregge queste situazioni. La tendenza delle donne a idealizzare l’aggressore, a credere che si, solo lui può salvarle, spesso si accompagna a quel vertice inconscio che infantilizza il partner: solo io posso salvarlo. Una sorta di desiderio onnipotente di essere solo lei a poterlo salvare, ad avere le chiavi giuste per farlo finalmente cambiare. E questo è l’altro viraggio della posizione della vittima. Donne che proteggono l’uomo, che lo assecondano, che occupano un discorso materno anziché promuoverne uno paritario.
Che privilegiando i bisogni e i desideri di questi uomini, involontariamente nutrono le loro pretese narcisistiche mai davvero riconosciute come tali. Donne che infantilizzano proprio perché non esigono responsabilità. Manipolazione e dipendenza sono orditi dalla stoffa di fantasmi e desideri primitivi la cui radice siamo tenuti a conoscere se vogliamo tentare di capire il fenomeno della violenza. Per l’essere umano non ci sono scorciatoie, ciascuno è chiamato a quel lavoro di umanizzazione che non ci risparmia dal fare i conti con la nostra spazzatura e la nostra mancanza. La violenza è il fallimento della civiltà e in questo fallimento, soprattutto quando si manifesta col suo volto più orrendo, siamo tutti implicati. Occorre pensare realmente come stiamo vivendo.
Occorre ripensare le relazioni storicamente costruite tra il maschile e il femminile abbandonando rivendicazioni strumentali, trovare nuove pratiche e nuove parole nel riconoscere che nella nostra società i ruoli e le funzioni rigidi e immodificabili non sono più attualizzatili e nemmeno auspicabili. Il movimento è irreversibile, ma dobbiamo non perdere la relazione con il senso. Un tempo le società patriarcali subordinavano i desideri dei singoli alla logica dell’ordinamento complessivo del sistema giuridico e sociale (il grande Altro). Per questo vigeva una rigida divisione dei ruoli e si costituivano identità stabili (segregazione del diverso), ciò che veniva chiesto in definitiva era di sottomettersi ad una legge sacrificale. E questo sacrificio era pagato soprattutto dalle donne e dai diversi che non a caso sono stati i protagonisti del sovvertimento avvenuto negli ultimi decenni del secolo scorso. Ma nel caos totale in cui siamo immersi, ha ancora senso parlare di società patriarcale? È ancora questo il discorso dominante? È il discorso semmai allucinato (purtroppo con seguito) in ogni forma di conservatorismo. In tempi di crisi incrociamo sempre forze regressive che vorrebbero ripristinare chissà quale ordine, sedotti da chissà quale paradiso perduto.
E guarda caso la regressione di cui si tratta ha il volto maligno del sessismo e del razzismo. Ma per chi non si riconosce in questo tipo di tentazione nostalgica, fare riferimento all’impianto patriarcale in un tempo in cui è completamente privato di autorità, non rende confuso e quindi pericoloso il dibattito culturale e politico in corso? A me pare che la violenza attuale si nutra dell’impotenza dell’impianto patriarcale, dell’impotenza conclamata del grande Altro della garanzia (che è sempre stata una illusione), mi pare che lo smarrimento del maschile sia legato ad una crisi d’identità senza precedenti. Il concetto d’identità è tra i più complessi da dipanare. Identità non vuol dire io=io, questo modo d’intenderlo è proprio del narcisismo e il narcisismo pare marcare abbondantemente il nostro tempo: soggetti sempre più autoreferenziali, in ritiro autoerotico, depressi, patologicamente soli. Il narcisista è incapace di riconoscere l’altro nella sua alterità, per lui l’altro è lo specchio che deve confermare il suo essere, per questo non è in grado di stabilire i propri limiti, sprofonda ovunque all’ombra di sé.
Ed è l’impianto narcisistico, temo, con il suo portato di rabbia, aggressività, avidità, distruttività e – come ha scritto Freud in quel vertiginoso testo del 1920, a ridosso del primo conflitto mondiale, Al di là del principio di piacere – autodistruttività ad avere la meglio sulle strutture psiche attuali. Non che il narcisismo sia una struttura, è piuttosto una tendenza e può favorire Eros o Thanatos, la pulsione di vita o la pulsione di morte. A me pare che la seconda tendenza innondi abbondantemente gli argini che faticosamente abbiamo istituito per mantenere un confine. Del reale, del vero, non siamo mai certi, ma non possiamo mai smettere di cercare di saperci fare e per approssimarci in questo compito abbiamo le parole, insufficienti ma necessarie per allenarci a vivere. Allora per superare la logica sadica e masochistica del dominatore e del dominato, per superare la legge perversa del disamore, dobbiamo darci strumenti adeguati, in primis mettendo a fuoco il significato dei concetti che utilizziamo. Chiediamoci perché la caduta delle illusioni ha effetti quasi sempre catastrofici anziché diventare occasione di crescita.
Evidentemente perché non siamo sufficientemente attrezzati, vale a dire formati, per affrontare la complessità che pur ci riguarda da vicino. Siamo disorientati e per questo ad esempio invochiamo il capo, il ritorno del capo. Il nostro tempo ha perso il senso del limite, se vogliamo il senso della Legge come bussola che orienta, la psicanalisi ha tradotto questo principio con il concetto del Nome del Padre quale fondamento ultimo del senso della legge simbolica: “non tutto è possibile” (non è un’ingiunzione sadica come spesso e confusamente è stata interpretata per carenza educativa, è piuttosto un principio creativo che rende possibile, vivibile, la vita: non puoi fare delle cose per renderne possibili delle altre. Il no è fondativo quanto il si). È un principio universale a cui – faticosamente e dolorosamente – siamo necessariamente assoggettati. È l’uscita dalle onnipotenti illusioni infantili, rispetto alle quali siamo tutti recalcitranti. Il “non tutto è possibile” deve trovare una sua attuazione che non passi dalla tentazione del capo o dalla logica sacrificale. La logica del capo è quella delle identificazioni: un capo si sopporta solo perché si vorrebbe essere come lui (il reale di questo costrutto è l’invidia), la logica sacrificale in definitiva è quella di rinunciare alla libertà, e tutti noi siamo tentati da questa rinuncia perché la libertà è faticosa, la libertà spaventa. Gli umani, questo uno psicanalista lo vede tutti i giorni, sono presi dal paradosso di voler essere liberi, ma di amare la schiavitù che li libera dal peso della libertà.
E a questa altezza si scombussolano tutti i discorsi e si fraintendono tutte le parole. La dipendenza patologica (che cos’è se non una forma di schiavitù?) è la risposta drammatica e talvolta tragica che traduce la portata potente di questo compito imprescindibile che ci riguarda. È preferibile la schiavitù alla libertà. Ma questa logica sacrificale ha in sé un’altra questione, più subdola, e che rinvia ad una aspettativa: faccio questo in vista di un risarcimento, di un ritorno del sacrificio compiuto. È il principio dello scambio, è la legge che sottende un principio economico (fondamentale ma non fondativo) che viene spesso confuso o barattato per dono. L’amore ha a che fare con il dono, non con lo scambio. Il dono si compie nell’atto di donare. L’amore si compie nell’atto di amare. È l’atto che ci avvicina al vero, purtroppo non è così frequente, ma solo l’atto può trasformare la nostra vita. E la cosa più paradossale è che non dipende neppure da noi, da noi dipende che lo impediamo. E questo, ancora più sfortunatamente, succede molto spesso.
C’è una nuova astuzia che si profila al nostro orizzonte e che apparentemente supera la logica sacrificale, è un cambio di paradigma che ha reso ancora più pervasiva la logica economica. Si tratta dell’astuzia della società della prestazione di cui parla il filosofo Bing-Chul Han. Il problema di questo nostro tempo non è quello di avere a che fare con delle identità rigide (totalitarismo immaginario della società patriarcale, che sopravvive nella fantasia di alcuni) ma al contrario, è quello di avere a che fare con delle identità fluide pronte ad adattarsi alle situazioni eccitanti che offre il mercato. La società della prestazione ha superato in astuzia la società della repressione e dell’obbedienza (patriarcale), perché illude tutti noi di essere liberi di fare quello che ci pare. Siamo passati dal “tu devi” al “tu puoi”, ma è solo un mero imbroglio, un’impostura, perché si tratta della libertà di consumare qualsiasi cosa (oggetti e soggetti) senza limite. È questa la nuova frontiera – seduttiva e maligna – con cui confrontarci perché una società sì fatta istituisce s-legami, vale a dire un mondo disumano. Solo ciascuno di noi può rispondere alla chiamata del desiderio di essere liberi, c’è un aut-aut da attraversare per poter pensare a nuove forme di legame.
Nessun Altro può svolgere questo compito al posto nostro se non vogliamo essere destinati al fallimento che si ripete quando manchiamo l’essenziale. La passione postmoderna per le apparenze, l’indifferenziato fusionale che fa scomparire l’alterità, rischia di favorire un’involuzione pericolosa perché nello s-legame avanza la violenza.

