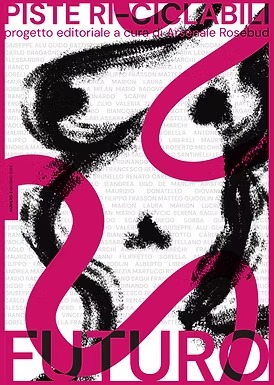
Futuro
Infiniti futuri
di Franco de Vincenzis
Che cosa ci riserva il futuro?
Che cosa ci riserva il futuro?
In mancanza di una sfera di cristallo, tutte le volte che ci apprestiamo a prefigurare scenari futuri e mondi possibili ci scontriamo con previsioni il più delle volte fallaci. Così, la riflessione attorno al futuro assomiglia a un esercizio probabilistico dove il caso gioca un ruolo decisivo. D’altronde, chi tenta per professione di perlustrare l’orizzonte venturo (cartomanti, astrologi, ecc…) non solo si arrischia su un terreno scivoloso di cui spesso è vittima ma, per giustificare i propri assunti, interpreta ‘ex post’ gli eventi sulla scorta di anticipazioni generiche, sempre efficaci alla bisogna. Paradossalmente, è risaputo, non si può guardare al futuro se in primo luogo non ci volgiamo al passato affidandoci a pensatori antichi e moderni che hanno riflettuto sul ‘non ancora’.
La storia del tempo futuro si divarica già a partire da Aristotele in due grandi
direzioni: quella indeterministica (De interpretatione di Aristotele) e quella necessitarista (Diodoro Crono). La prima, come è noto, conduce lo Stagirita a una sospensione di giudizio riguardo alle proposizioni contingenti riferite al futuro quanto al loro status di verità o falsità, sospensione risolta in senso positivo o negativo allorché si verifica o meno l’evento anticipato nella proposizione. La seconda tesi, ripresa da Spinoza e da tutti i deterministi, considera il futuro un effetto necessario della causa o delle con-cause che lo hanno determinato. Mentre nel primo caso viene reciso il nesso tra causa ed effetto con l’appello alla contingenza, nel secondo è proprio tale nesso che regge il determinismo nel verificarsi dell’evento futuro, nonché la sua verità. È vero, altresì, che lo stesso Aristotele non considera totalmente indeterminata la verità o falsità della proposizione nell’atto della sua formulazione, dato che la realtà contingente descritta nella stessa è ‘gravida’ di possibilità future che possono verificarsi. Pur essendo possibile (e dunque contingente) il verificarsi dell’evento futuro, esso deve sottostare al principio di non contraddizione e al nesso potenza-atto.
L’argomento necessitarista di Diodoro Crono si basa, invece, sulla logica modale (essere possibile o necessario): date le cause, ne consegue di necessità, e inevitabilmente, l’effetto. Secondo il filosofo megarico esistono eventi assolutamente necessari che non possono essere altrimenti in nessuno ‘stato di cose’ possibile, e quelli condizionatamente necessari che potrebbero essere diversi in uno stato di cose differente. Una delle obiezioni rivolte ai necessitaristi, oltre all’assenza di libero arbitrio, è il fatto che le cause che generano l’effetto possano essere non deterministiche e quindi contingenti.
Il tema del futuro contingente, in epoca medievale, si intreccia progressivamente con la questione spinosa del rapporto tra prescienza divina e libero arbitrio dell’uomo. Se i nominalisti Duns Scoto e Guglielmo da Ockham, seppur con alcuni importanti distinguo, considerano il futuro ‘aperto’ e gli atti contingenti assolutamente liberi, Tommaso d’Aquino, riprendendo in parte la tradizione agostiniana, statuisce la conoscibilità da parte di Dio di tutti i futuri possibili, data la sua infinità. Non essendo limitata nel tempo, qualunque scelta umana, presente e futura, è conoscibile a Dio, secondo l’Aquinate. La conoscibilità, ovviamente, non comporta determinismo poiché, come ribadirà la ‘seconda scolastica’, la prescienza divina non determina a priori le decisioni umane, le quali restano pertanto perfettamente libere. Tali questioni sono fin troppo note e complesse per essere esaminate in questa sede. L’accenno basti a demarcare il nostro ambito di azione e di riflessione.
Nel corso dei secoli la questione è stata ripresa da autori come Gottfried Wilhelm Leibniz il quale, nei Saggi di Teodicea e nei Nuovi saggi sull’intelletto umano, esplicita il suo ‘determinismo’ da armonia prestabilita. Il ‘futuro contingente’, analizzato in particolare nel Discorso di metafisica, pur sembrando indeterminato a seguito della nostra limitata comprensione delle leggi del mondo, è determinato secondo un ordine che sfugge all’uomo. Il celeberrimo ‘principio di ragione’, che il filosofo di Leipzig adotta per giustificare qualsiasi accadimento, mostra con nitidezza che non possono sussistere fatti ‘insensati’ o casuali: ogni evento ha la sua ragione. In tutti gli autori finora esaminati il futuro nasce dalla proiezione in un tempo x+1 di esperienze vissute nel tempo x, il che sembra quasi inevitabile.
Il Novecento non fa eccezione: sia il ‘futuro passato’ di Koselleck, sia il ‘futuro anteriore’ di Benjamin di fatto non trattano del ‘futuro’ ma rispettivamente del ‘presente storico’ e del ‘presente messianico’. Il padre della ‘semantica dei tempi storici’ ribadisce che il significato di un concetto storico si evolve e viene reinterpretato in base alle categorie temporali del presente. Similmente, l’autore delle
celebri Tesi di filosofia della storia considera il tempo messianico non in prospettiva religiosa, ma come tempo di crisi e di svolta, un tempo che favorisce i sovvertimenti e spezza la linearità del procedere storico. Il “tempo-ora” (Jetzt-Zeit) di Benjamin è l’attimo della decisione radicale e collettiva che consente l’emergere delle forze del cambiamento.
Non si discostano da questo modello nemmeno Konrad Lorenz e Karl R. Popper i quali, seppur da presupposti differenti, concordano sull’apertura del futuro: il primo poiché il comportamento animale e umano è condizionato da fattori biologici e ambientali, quindi non predeterminato rispetto a un codice genetico; il secondo perché ogni conoscenza scientifica è un’ipotesi provvisoria ‘falsificabile’, quindi nessun fatto contingente venturo può essere determinato a priori da una congettura.
Sul versante psicoanalitico è stato Wilfred Bion a mettere l’accento sul tempo futuro, tempo che svolge un ruolo decisivo nella sua idea di mente e di apprendimento. Bion ritiene che la mente umana sia caratterizzata da una tendenza innata all’apprendimento e allo sviluppo. Ma per prepararsi al futuro la mente cerca di comprendere e di dare significato alle esperienze del presente. La caratteristica saliente dell’essere umano che permette, secondo Bion, di tollerare l’incertezza del futuro e di affrontare l’ignoto è la sua capacità di pensiero (thinking capacity). Tale capacità consente alla mente di restare flessibile e aperta verso le novità dell’evento futuro imprevedibile, di adattarsi alle nuove situazioni e di rivedere le proprie acquisizioni del passato con spirito critico ed esplorativo. Ecco perché il pensiero, secondo Bion, è ‘senza pensatore’, non è possesso esclusivo del suo portatore e pertanto non costringe o incanala l’attenzione secondo le direttive di colui che pensa.
L’attenzione, così, resta ‘fluttuante’ e aperta verso la scoperta di nuovi significati della realtà.
Il primo a operare una cesura netta con le predizioni ‘metafisiche’ del passato è stato Nietzsche il quale, con ‘la morte di dio’ e la trasvalutazione di tutti i valori, ha indicato la via per l’oltrepassamento della metafisica. Il domani non è la prosecuzione dell’oggi con altri mezzi (e fini), ma può essere solo in radicale discontinuità con il passato di cui non c’è più traccia, né memoria. Ecco perché il futuro è ‘impensabile’ e inquietante. Al contrario, come ricorda Galimberti3, tutte le narrazioni del tempo ‘escatologico’, da quella giudaico-cristiana alle versioni laiche in forma di utopia, rivoluzione, fino alle più recenti teorie sociologiche e psicoanalitiche, hanno come comun denominatore la struttura tripartita di un passato primordiale (traumatico) da superare, di un presente della cura e di un futuro positivo in cui è riposta la speranza del rinnovamento (guarigione). In tali ‘visioni’ il futuro è sempre gravido di risoluzioni, è terapeutico ed è forse per questo che l’orientarsi verso il sol dell’avvenire ‘guarisce’ un presente fatto di oppressione e/o di passiva accettazione del dato di realtà. Al contrario, in un futuro di radicale discontinuità, come quello preconizzato da Nietzsche e inverato nell’epoca del nichilismo, ospite inquietante, i quadri del passato risultano inservibili e il domani appare come un’alba nuova, tutt’altro che rassicurante. La libertà ‘radicale’ che ne risulta porta con sé un carico di inquietudine intimamente connesso al labirinto infinito di percorsi che si aprono nell’attimo della decisione. Tuttavia, questo labirinto di infiniti futuri, proprio a causa della sua indeterminatezza e indefinitezza, mostra il suo fascino grazie all’apertura di innumerevoli futuri compossibili, possibilità che si risolvono nell’attimo della decisione, la quale inibisce, però, la percorribilità delle vie alternative (Heidegger). Ogni atto di libertà, per semplificare, riduce le possibilità di scelta ulteriore perché, contemporaneamente, sfumano nel passato chances inesplorate che si accumulano in attesa di redenzione (Benjamin).
Il rischio dell’apertura totale verso un mare di futuri possibili è anzitutto quello del vagare ramingo, senza meta, tipico del viandante o dell’errante4. In realtà, allo smarrimento del girovago fa da pendant lo sguardo stupefatto dell’esploratore che si avventura lungo sentieri ignoti ed erranti. In ogni tratto di questo vagare pionieristico c’è potenzialmente, accanto al rischio, l’opportunità di scoprire universi inesplorati e di creare nuovi mondi.
Un radicale e alternativo modo di riferirsi a mondi possibili è stato quello di Nelson Goodman, il quale si è occupato della loro ‘semantica’, soffermandosi sull’esistenza di mondi alternativi, accanto a quello che percepiamo, che si costruiscono attraverso il linguaggio. Secondo Goodman, modificando le proposizioni linguistiche in senso controintuitivo rispetto a quanto percepiamo non enunciamo frasi insensate, bensì rimandiamo ad altri mondi in cui l’enunciato è vero. L’esempio classico della proposizione ‘tutto il grano è verde’ sta a indicare che, sebbene nel nostro mondo un tale enunciato sia chiaramente falso, esiste un mondo alternativo in cui esso è vero.
Tutto dipende dall’uso del predicato ‘verde’ in un determinato tempo storico. Tale affermazione è un corollario della sua generale ‘teoria dell’induzione’ in base alla quale non è possibile proiettare su altri esempi predicati ‘trincerati’ (come ‘verde’) all’interno di un enunciato specifico senza che prima siano stabiliti i criteri per il suo utilizzo. In altri termini, ogni problema filosofico (analitico) è ‘degradato’ a problema storico o di contesto d’uso. Pertanto, ciascuna previsione futura di un evento è valida solo all’interno di un sistema di riferimento ben definito che tiene conto dell’uso passato dei predicati ‘trincerati’. Tra i ‘mondi possibili’, come è noto, vi è il ‘mondo dell’arte’ che, ad avviso di Goodman, rappresenta il topos culturale significativo all’interno del quale un’opera d’arte trova compimento e senso.
Chi ha ripreso, invece, il tema del ‘futuro contingente’ dandone una connotazione logico-temporale, è stato filosofo e matematico neozelandese Arthur N. Prior. La teoria di Prior, nota come ‘logica del tempo’, apre a un futuro indeterminabile a partire dal presente. Nei confronti del futuro, secondo Prior, bisogna adottare aristotelicamente una sorta di epoché, sospendere il giudizio, perché gli eventi venturi contingenti non sono ancora determinati. Tuttavia, rispetto ad Aristotele, l’epoché non si risolve in un senso positivo o negativo nell’atto dell’accadimento perché il tempo a venire resta comunque indefinito. Quindi il futuro è aperto a infinite possibilità di sviluppo, anche al di là della concezione lineare del tempo e della relazione simmetrica tra passato, presente e futuro.
Prima di portare a sintesi queste rapide riflessioni è opportuno richiamare un’ultima versione semantica dei mondi possibili. Si tratta della ben nota teoria di Saul Kripke che si pone come alternativa alla logica modale fondata sull’antitesi oppositiva tra possibilità e necessità. I mondi possibili, secondo Kripke, potrebbero essere ‘strutturalmente’ diversi dal mondo attuale. Pertanto, il filosofo e logico di Princeton si interroga su quale significato, in termini di verità, abbiano gli enunciati modali (necessità e possibilità) nel mondo attuale e nei mondi possibili. La posizione ‘concettualista’ di Kripke, a cui si oppongono le teorie più nominaliste (B. van Fraassen), realiste (D. K. Lewis) e attualiste (A. Plantinga) ribadisce che i ‘mondi possibili’ sono costrutti mentali grazie ai quali siamo in grado di stabilire se un enunciato è contingente (se vero almeno in un mondo possibile) o necessario (se è vero in tutti i mondi possibili).
Questi brevi cenni allo sviluppo storico dell’idea di futuro, sono il quadro cornice all’interno del quale andiamo a collocare una riflessione più articolata su futuro e possibilità potenziali.
Partiamo dalla lingua dei ‘maggiori’. Come è noto, l’infinito futuro attivo latino si forma con il supino e la terminazione all’accusativo e si traduce in italiano col futuro della subordinata, nel caso in cui la reggente ha un tempo presente, ovvero con il condizionale passato se la reggente ha un tempo storico: per esempio, “ritengo che la scienza vincerà (existimo scientiam victuram esse)”, “ritenevo che la scienza avrebbe vinto (existimabam scientiam victuram esse)”.
La struttura dell’infinito futuro attivo latino, al di là della corretta traduzione italiana, si presta a originali usi ‘filosofici’ volti a definire le aperture infinite e com-possibili del futuro. Se ci soffermiamo sull’infinito futuro di ‘vinco,is’, cioè ‘victuram esse’ letteralmente possiamo tradurre con ‘essere per vincere’, il che implica a livello ontologico un Esserci (Dasein) ‘futuro’ in grado di vincere o pronto a vincere. La previsione dell’esito futuro implica la presenza di un Dasein che permane nel tempo e garantisce, con la sua permanenza, stabilità e continuità. Il futuro aperto dall’infinito latino si situa, quindi, all’interno di un’ontologia classica ben determinata che non ammette ‘vuoti’ o ‘salti’ (natura non facit saltus). Ma il futuro può essere concepito solo in questa continuità? E se fosse in totale e radicale discontinuità con l’Esserci presente e storico? In altre parole, e se il futuro fosse totalmente altro?
Il breve percorso di ricognizione delle diverse (e a volte opposte) visioni di futuro contingente o necessario, del connesso problema teologico del rapporto tra prescienza divina e libertà umana, del problema psico-antropologico della capacità umana di affrontare l’incertezza del futuro e, da ultimo, degli aspetti logico-modali della semantica dei mondi possibili, nelle sue diverse accezioni e declinazioni, ci aiuta ora a riformulare gli interrogativi precedenti in termini differenti: se il futuro è totalmente ‘altro’ rispetto al presente, in totale discontinuità con il passato, non suscettibile a ‘verifica’ nel tempo (data la non linearità dello stesso) quale prospettiva ontologica è possibile? In altri termini, se il nostro Esserci (Dasein) è inutilizzabile nel futuro a causa della discontinuità del tempo, se la ‘prospettiva’ heideggeriana di essere-per-la-morte, come autentica modalità dell’Esserci, rimanda alla possibilità più certa e incondizionata, ma nulla asserisce relativamente al futuro personale, se non che ogni progetto, in quanto determinazione nel tempo, genera angoscia e, con essa, la ‘colpa’ per la perdita di infinite altre possibilità, allora ogni riferimento al futuro resta una possibilità impossibile. Lo stesso riferirsi al futuro al singolare è fuorviante poiché proietta linearmente su un ‘locus’ ontologico inconoscibile il nostro ‘modus essendi’ presente e temporale. Più corretto, a mio avviso, sarebbe parlare di ‘infiniti futuri’, non come un’infinità di loci coesistenti e compossibili ma di ‘infinite modalità di futuro’. Il che apre a ontologie differenti e a dimensioni spazio-temporali (ontiche) distinte, finanche antitetiche. Insomma, ‘del doman non v’è certezza’. Ogni previsione rassicurante, ogni tentativo di determinare gli eventi venturi (dalle previsioni meteo ai disastri ambientali, dagli investimenti finanziari alle scommesse sportive, e via discorrendo) si scontra con il limite ontico nel quale siamo costretti.
Immaginare, ad esempio, lavori futuri a partire dalle esperienze passate, si rivela spesso operazione fallace: chi avrebbe mai pensato venti anni fa che tra i mestieri del futuro ci sarebbe stato l’influencer! Eppure, proprio perché l’inimmaginabile si squaderna con tutto il portato di spaesamento e meraviglia, di disorientamento e stupore, gli infiniti futuri che ci attendono, abitati da Esserci ‘oltre-umani’, post-umani, da cyborg, da intelligenze artificiali e via discorrendo e fantasticando, sono anche ‘modalità’ diverse e libere di immaginare il nostro essere possibile e, allo stato attuale, imperlustrabile. Modalità che potrebbero rivoluzionare nel bene e nel male l’habitat in cui viviamo, trasformare le città (magari rendendole vivibili e non solo per la specie umana) e i linguaggi (e, con essi, concetti e pensieri) e rimettere in discussione tutti i capisaldi su cui poggia la nostra ‘civiltà’. Non è detto che questi ‘infiniti futuri’ siano necessariamente una sciagura.
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ESSENZIALI
Bion, Wilfred, Memoria del futuro: il sogno, tr. it. a cura di A. Baruzzi, Cortina, Milano 1993
Id., Memoria del futuro: presentare il passato, tr. it. a cura di P. Bion Talamo e A.
Baruzzi, Cortina, Milano 1998.
Id., Memoria del futuro: l’alba dell’oblio, tr. it. a cura di A. Baruzzi, Cortina, Milano 2007.
Duns Scoto, Lectura, I, d. 39, in Intorno al futuro: volontà e contingenza secondo Duns Scoto, a cura di E. Dezza, A. Nannini e D. Riserbato, Edizioni Antonianum, Roma, 2023.
Galimberti, Umberto, L’etica del viandante, Feltrinelli, Milano 2023.
Goodman, Nelson, La struttura dell’apparenza, tr. it. a cura di A. Emiliani, Il Mulino, Bologna 1985.
Id., Fatti, ipotesi e previsioni, tr. it. a cura di C. Marletti, Laterza, Roma-Bari 1985.
Id., I linguaggi dell’arte, tr. it. a cura di F. Brioschi, Il Saggiatore, Milano 2017.
Heidegger, Martin, Essere e tempo, tr. it. di P. Chiodi, Longanesi, MIlano 1976.
Lorenz, Konrad – Popper, Karl R., Il futuro è aperto: il colloquio di Altenberg insieme con i testi del simposio viennese su Popper, tr. it. a cura di D. Antiseri, Rusconi, Milano 1989.
Kripke, Saul, Nome e necessità, tr. it. di M. Santambrogio, Boringhieri, Torino 1982.
Leibniz, Gottfried Wilhelm, Discorso di metafisica, tr. it. a cura di G. Saponaro.
Bibliosofica, Roma 2014.
Ockham, Guglielmo da, Il Trattato sulla predestinazione e prescienza divina riguardo ai futuri contingenti di Guglielmo di Ockham, introduzione, testo, traduzione e commento a cura di R. Fedriga e R. Limonta, Città Nuova, Roma 2019.
Prior, Arthur, Norman, Past, present and future, Clarendon, Oxford 1978.
Tommaso d’Aquino, Somma contro i Gentili, Libro I, cap. LXXXV, tr. it. di T. S. Centi, Utet, Torino 1997.

