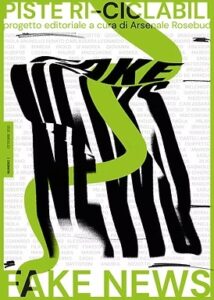
Fake news
Caveat emptor, stia attento l’acquirente
di Francesco Berton
Perché acquistiamo un determinato prodotto? Come lo scegliamo? Quando decidiamo di fare un acquisto siamo convinti che sia una scelta consapevole, fatta dopo esserci informati, su riviste, in rete, chiedendo ad amici – tu come ti sei trovato? – e alla fine siamo convinti di sapere tutto sul prodotto e sull’azienda produttrice. In realtà non possiamo che arrivare ad avere una piccola parte di informazioni utili sul prodotto, perché chi lo produce e lo vende ne saprà sempre di più di chi lo acquista. È l’asimmetria delle informazioni tra venditore e acquirente, la cui importanza nelle contrattazioni è stata evidenziata per primo da George Akerlof, premio Nobel per l’economia nel 2001. Quindi, se non possiamo conoscere ciò che scegliamo, perché lo scegliamo? Semplicemente fidandoci di chi lo vende o delle nostre sensazioni. Perché dove non arriva la conoscenza ci dobbiamo mettere la fiducia, che è la componente preponderante alla base di ogni scelta. Quello che non so si presenta come dubbio. La fiducia mi serve per eliminare i dubbi e decidere. Perché l’acquisto è un contratto e devo aderire o non aderire. Sono il nostro istinto e le emozioni a dirci se dobbiamo fidarci o no. Ma poi istinto ed emozioni le accantoniamo, perché sono soggettive e quindi responsabilizzanti. Conviene fidarsi e creare un qualcosa in cui credere, al quale poi imputare la colpa, nel caso di scelte sbagliate. Chi vende sa benissimo che suscitare un’emozione è più importante del prodotto in sé, che per vendere non serve soffermarsi più di tanto a spiegare caratteristiche concrete. Meglio lavorare su un’idea e su una sensazione che il prodotto può evocare. D’altro canto, i consumatori pesano sempre più aspetti che vanno oltre il prodotto in sé, cercando informazioni sull’azienda produttrice e sulla sostenibilità del suo impatto ambientale, sociale e di governance (i famosi criteri ESG). Razionalizzare la scelta e renderla frutto di un ragionamento richiede fatica, valutazione di pro e contro, ricerca, analisi ed elaborazione di informazioni, pur sapendo che le emozioni avranno sempre peso. Ormai anche l’economia ha smesso di basare le sue teorie su un ipotetico homo oeconomicus (un inesistente essere perfettamente razionale che sceglie sempre ottimizzando i suoi vantaggi), per entrare negli oscuri meandri della scienza comportamentale, dove irrazionalità e scelte emotive pesano anche nelle scelte economiche (se no, perché esistono le bolle?). Perché le scelte sono più emozionali che razionali. L’homo oeconomicus è sempre stato solo teorico perché è impensabile che le stesse persone che si affidano a maghi e imbonitori di turno diventino improvvisamente razionali quando si tratta di fare scelte economiche. Un diverso discorso andrebbe fatto per il campo della speculazione finanziaria, dove le fake news possono assumere le sembianze di pre-verità, profezie autoavverantesi che hanno il potere di influenzare i mercati finanziari, determinando negli operatori comportamenti tali da dare concretezza alle profetiche news.
A volte la ragione arriva dopo, per far sembrare frutto di una scelta ragionata ciò che in realtà ho già deciso d’istinto, ascoltando le emozioni. Altre volte mi affido totalmente senza sapere nulla di ciò che compro. Acquistiamo prodotti tecnologici sofisticati senza avere idea delle effettive caratteristiche tecniche, ma siamo convinti di avere fatto una adeguata valutazione della qualità in rapporto al prezzo. Assumiamo medicine senza neppure estrarre il bugiardino dalla scatola. Sottoscriviamo prodotti bancari e assicurativi senza leggere neppure una riga del foglio informativo. Compriamo azioni non quotate della nostra banca locale, fiduciosi che si tratti della forma più sicura di investimento (mentre è una delle più rischiose) perché così ce le ha presentate l’impiegato allo sportello, di cui ci fidiamo. Qui però c’è un ulteriore elemento: un veicolo che raccoglie la mia fiducia e la indirizza. Per le imprese è la forza acquisita dal brand, il marchio che attraverso la pubblicità si insinua nelle nostre vite, diventa un qualcosa di noto, un amico verso il quale diventiamo ben disposti. Perché fidarsi alla fin fine è una scorciatoia che ci risparmia la fatica di cercare informazioni e di analizzarle. Oppure perché non abbiamo alternativa. La pubblicità non è vera, è una rappresentazione esagerata. Ma la accettiamo, nella sua finzione. Perché conosciamo il suo scopo, che è quello di vendere e quindi di guadagnare.
Quand’è allora che il fake rappresenta un problema? Solo se l’inganno non è palese ma è nascosto?
Posso comprare la borsetta di una famosa casa di moda in un negozio di una via prestigiosa del centro città, oppure posso comprarla da un improvvisato venditore che la espone su un telone steso su un marciapiede. Sembrano due borsette identiche, ma so che nel secondo caso è un falso. Lo so perché il prezzo è infinitamente inferiore, ma soprattutto lo so in base a chi me la propone. L’inganno è palese perché so distinguere la fonte. Posso decidere di comprare il prodotto falso, ma lo faccio consapevolmente, senza grandi aspettative, sapendo che non durerà molto e potrebbero aprirsi le cuciture e sfaldarsi il tessuto dopo poco tempo. Il problema nasce quando non sono in grado di distinguere la qualità in base alla fonte. Quando ogni proposta mi sembra comparabile, da chiunque provenga. E allora finisco per fidarmi di fonti che in modo doloso creano false informazioni.
In altri casi è lo scopo a non essere palese. Perché, ad esempio, esistono campagne di martellante propaganda a favore di qualsiasi (qualsiasi!) cura medica che non sia tra quelle della medicina ufficiale? In questi casi non sembrano esserci reali interessi economici in gioco, anche se qualcuno in effetti ci guadagna. Sono campagne che sembrano non avere uno scopo palese, ma solo quello di mettermi in guardia: dai vaccini, dai medici cattivi della scienza ufficiale, dalle finte verità istituzionali, dai pericoli della scuola pubblica che corrompe i giovani, dalle losche figure tramanti dei miliardari che osano donare soldi a favore di cause progressiste, dai complotti orditi all’ombra delle verità ufficiali. Qual è allora il loro scopo? Il comune denominatore di queste campagne è quello di creare una sfiducia generalizzata verso la democrazia, le sue istituzioni, chi le appoggia e chi cerca di rappresentarle degnamente. Screditando le istituzioni porto la gente a non fidarsi più delle informazioni provenienti dalle fonti ufficiali e di quelle legate in qualche modo all’establishment. Meglio credere all’amico che ti parla sulla rete, credi a lui, che tutti gli altri vogliono fregarti e non te la raccontano giusta. Inoltre, creando un caos informativo induco la gente a pensare che la libertà non funziona e che bisogna limitarla. Dobbiamo quindi temere chi finge di agire per difendere la libertà e in realtà ne abusa. Perché induce a pensare che la libertà non funziona, che ci vorrebbe una stretta autoritaria per far andare meglio le cose. Tutto questo, quindi, è per prepararmi come cittadino ad accettare qualcos’altro, che dovrebbe arrivare al posto della democrazia (che è inefficiente e vuole il mio male) e “mette le cose a posto”. Serve a creare l’infantile desiderio dell’uomo forte che mi protegge e mette in riga tutti quelli che mi fanno del male. Ma sappiamo bene cosa può esserci al posto della democrazia. Ce lo dice la storia e non è un racconto che parla di libertà. Creare una sfiducia generalizzata mina alla base il collante sociale, con conseguenze imprevedibili ma prevedibilmente governabili solo in modo autoritario.
Una falsa informazione che effetti può produrre? Sarà davvero in grado di far cambiare idea a qualcuno o ciascuno crede solo a informazioni che rafforzano ciò che già pensa? O, piuttosto, non si tratterà di informazioni artefatte prodotte proprio per soddisfare un bisogno? È evidente che dietro a molte fake news ci sono organizzazione, lavoro e investimenti, per cui si può parlare in questi casi di un prodotto e non di un passatempo per isolati volontari paladini di qualche ideologia. Ed è un’attività sicuramente proficua perché, a differenza di giornali e dei canali informativi “ufficiali”, non c’è rischio economico né responsabilità. Non ho la preoccupazione di bruciare il “brand”, perché la fiducia di cui godo si basa su una propaganda slegata dai fatti, emotiva e inattaccabile dal ragionamento. Nulla può contrastare la mia attività e posso cambiare idea quando voglio. Posso sostenere una cosa o il suo opposto liberamente, senza dover rendere conto di quanto fatto o detto in passato (servono esempi?).
Se le fake news sono un prodotto con un’offerta strutturata, ci sarà quindi anche una domanda. Chi ha bisogno delle fake news? Le fake news hanno successo perché avvalorano ciò che la gente ama credere, perché vanno incontro ai desideri di molti e quindi vanno bene così. D’altronde, perché dovrei preoccuparmi di verificare una notizia che aderisce perfettamente ai miei desideri? Di fronte a una realtà che non capiamo, che ci appare nemica o che semplicemente non ci piace, ci creiamo una bolla idealizzata e ci predisponiamo ad ascoltare tutte le narrazioni conformi a questo mondo ideale. I fatti si adeguino pure al mondo come lo voglio io, popolato solo da gente fatta come piace a me, dove non si pagano le tasse, dove i soldi si possono stampare a volontà e dove le colpe di ciò che non va nella mia vita sono sempre di qualcun altro.
Ma se subisco gli effetti di una informazione falsa, è colpa mia? Caveat emptor, stia attento l’acquirente. È un principio del diritto romano, ancora oggi vigente nel mondo anglosassone, ma altrove più spesso mitigato da tutele a favore dell’acquirente. È comunque un principio che in un certo senso legittima l’inganno palesato dal venditore e pone nell’acquirente la responsabilità di ciò che acquista. In Italia il principio è più sfumato e prevede la responsabilità dell’acquirente solo nel caso di incauto acquisto, quando il difetto era del tutto evidente, o se il venditore ha dolosamente negato la presenza di vizi. Qual è il limite? Nel 1986, una azienda del cuneese aggiunse del metanolo a del vino di bassa qualità per alzarne la gradazione alcolica. Poteva farlo aggiungendo semplice zucchero, ma, per la ricerca di profitto senza scrupoli, preferì il metanolo, perché costava ancora meno. Il metanolo, se assunto, provoca danni neurologici. Molte persone morirono e altre rimasero cieche per aver bevuto quel vino, che venne venduto nei supermercati. Lo Stato al tempo trovò i fondi per aiutare il settore vinicolo, che subì un calo drastico dei consumi a causa di questo episodio, ma non per aiutare le vittime e i loro parenti, che non ebbero nessun risarcimento. Il vino era una barbera, tipologia di vino di alta qualità, che non potrebbe essere venduto a un prezzo anormalmente basso, come invece avvenne per quel vino. Alla fine, furono quindi le vittime a risultare colpevoli di “incauto acquisto”. Caveat emptor, appunto.
Le fake news sono sempre esistite, notizie manipolate dal potere costituito o da chi aspira ad esserlo. Nella storia, chi ha professato verità scomode è stato spesso perseguitato, chi ha divulgato fake news quasi mai e già questo è un indizio per capire da che parte stanno. Ma oggi se ne parla perché il fenomeno è dilagante, per quantità e qualità. Lo è di certo per effetto dei mezzi di diffusione capillare offerti dalla tecnologia a dalla sua accessibilità, ma non basta questo a giustificarlo. Il problema è che non c’è nulla che può fermare la creazione di fake news (si intende senza rilevanza penale). Dovrebbero in primis esistere dei limiti morali in chi pensa di crearle – non mentire, è ancora un peccato? – ma sono ampiamente superati dai costumi sociali e da chi dovrebbe dare l’esempio. Gioverebbe di sicuro la medicina che cura tutti i malesseri sociali: la ripresa economica. La fiducia e l’ottimismo portati dal benessere economico di nuovo crescente svuoterebbero i serbatoi del rancore, della paura e dell’incertezza sul futuro che alimentano il mercato delle fake news. Nell’attesa, non resta che l’argine culturale eretto da chi le riceve. Per farlo serve capacità di analisi e senso critico, ovvero più istruzione. Il tasso di abbandono scolastico dovrebbe quindi diventare un indicatore di salute di una società più importante del PIL. Perché è da qui che si alimenta il bacino dei fruitori di fake news, con tutte le crescenti conseguenze sociali. Stagnazione economica, strumenti tecnologici al servizio della propaganda capillare, limiti etici dissolti e istruzione trascurata da decenni: un mix che messo in mano a chi sa approfittarne crea una grossa nube sul nostro futuro. Stiamo attenti, acquirenti della democrazia.

