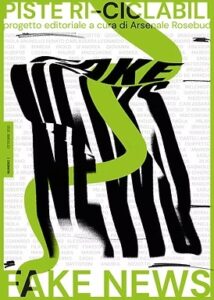
Fake news
Le Fake News: tra verità e realtà
di Paul Zilio
A) Realtà e verità. La verità non è mai pacifica. E’ una lotta tra interpretazioni, tutte soggettive, determinate dalla posizione in cui si trova chi interpreta. Ma nello stesso tempo non potremmo considerarla il risultato di un processo il quale conserva e trasforma tutti gli eventi, o pseudoeventi, in una superiore riconciliazione? Riconciliazione che sancisce la realtà di fatto, come ci insegna Hegel?
Nella rete dei processi interpretativi, i quali sviluppano delle rappresentazioni della realtà, il soggetto, spesso con la forza, tende a piegare la realtà secondo un progetto che si è dato. Il progetto è rivolto al futuro e quindi l’analisi della realtà qui e ora si confonde con i propri desideri ed inclinazioni, con la propria volontà: la realtà si traveste e inficia la verità in quanto tende a mescolarsi con inclinazioni, desideri o aspirazioni personali, a volte del tutto velleitari, che producono forme di “realtà contaminata” perdendo di vista appunto quella effettiva. Se supponiamo che verità e realtà possano arrivare a coincidere, a identificarsi, il loro aderire è, però, il risultato di una sorta di tensione, di conato (sforzo) in senso spinoziano, che spinge e piega i fatti entro un orizzonte in cui i “progetti” soggettivi, rivolti a un futuro, tendono a determinare, a contaminare appunto la realtà stessa. In altre parole, nel gioco dialettico tra realtà e verità si produce un’ombra, una sorta di campo magnetico che svia dal puro e semplice dato di fatto (se il puro e semplice dato di fatto può essere pensabile e quindi comunicabile). Le connessioni, o meglio la lotta, tra essere e dover essere, tra reale e ideale si contorcono sino a condensarsi in un risultato simile a un “blob” quasi inestricabile: insomma una rete di contaminazioni producenti la realtà così come si presenta. Ma come si presenta allora? Accettiamo e giustifichiamo il già dato? (Sembra che Napoleone ripetesse più volte: ” La storia è un insieme di menzogne su cui ci si è messi d’accordo”).
Se il nostro essere progettanti inficia nel suo sorgere la possibile lettura della realtà, nondimeno il pregiudizio, l’ideologia, l’ignoranza e la paura tendono a fuorviare, attraverso forme interpretative perverse, la conoscenza del reale. Ma ognuno di noi può davvero pensare di non essere in qualche modo priogioniero o della propria ignoranza o della propria malafede o dei propri pregiudizi? Ce ne possiamo liberare? Fino a che punto?
B) Realtà effettuali e interpretazioni. Partiamo da un altro punto di vista: nella realtà ciò che è evidente, lo è di per sè, secondo una logica dell’osservazione che vuole essere fotografica e di conseguenza iperrealistica, ma soprattutto dominata dalla tecnica; una realtà che sembra non avere bisogno di spiegazioni. Ma a quale realtà facciamo riferimento se non ne facciamo diretta esperienza? Dobbiamo confrontarci con e ripensare a qualcosa che ci è stato dato: immagine, filmato, fotografia, comunicazione ansa, articolo di giornale ecc… In ogni caso, che la fonte sia diretta o indiretta, abbiamo la necessità di interpretare e comunicare la nostra esperienza – diretta o indiretta- di quell’evento o fatto. La dobbiamo tradurre in pensiero e di conseguenza in parole e dobbiamo trovare le parole più adatte a descriverla. In questo percorso di traduzione è chiaro che entrano in gioco la memoria ma anche la capacità espositiva del singolo. In questa dinamica si aprono delle mancanze, dei vuoti, oppure l’incapacità di registrare l’esperienza stessa. Inoltre noi siamo già orientati nell’ascolto del nostro pensiero, poichè il nostro essere ha una storia che è la storia di tutte quelle esperienze e percezioni che rappresentano il nostro essere persona, in quanto sensibilità e intelligenza.
Abbiamo quindi bisogno della parola, di usare un linguaggio il più possibile chiaro e trasparente, tuttavia la parola è già una forma di rappresentazione e, nel suo farsi in quanto risultato di una riflessione, si allontana dall’immediatezza dell’evento, traducendolo e così tradendolo. La parola tradisce, il linguaggio è velenoso, o meglio il linguaggio è ambiguo e a seconda del pre-giudizio può essere salutare oppure velenoso. La parola non è un campo neutro, è un conflitto di interpretazioni come affermato precedentemente. Ma fino a che punto il linguaggio inteso come ordine razionale, in quanto strutturato da una grammatica, riesce a dire ciò che di per sè è forma di esperienza di un profondo sentire e che si diffonde e attraversa il nostro corpo? Certo possiamo avvicinarci, possiamo decidere di metterci alla ricerca della verità. Ciò presuppone un essere in cammino, un lungo cammino di avvicinamento. E presuppone un lavoro, una fatica creativa.
Se ci spostiamo nell’attualità, con la rivoluzione digitale in atto, si aprono problemi di una certa rilevanza: oggi uno studente medio quante parole conosce in una società dominata dall'”homo videns”? D’altronde la povertà del linguaggio non corrisponderebbe forse a una povertà del pensiero? Se dunque il nostro linguaggio è limitato non sarà forse limitato anche il nostro pensiero? E se ci spostiamo nel campo dell’informazione i problemi forse non si aggravano? Il problema implicito del sistema dell’informazione è che deve monetizzare, il suo intento è ideologico, deve creare consenso, deve accontentare quello che i lettori vogliono. Fino a che punto l’informazione è libera, non è forse determinata dai suoi interessi particolari? Ogni forma di potere detiene o cerca di controllare ogni forma di informazione e di conseguenza ancora una volta, oltre al problema della conoscenza, si aggiunge il problema della manipolazione. A partire da queste condizioni di chi possiamo fidarci? E questo comporta un ulteriore aggravamento della situazione, in quanto nel momento in cui ognuno sospetta di tutti e non si fida di nessuno scatta il meccanismo del “complotto”.
C) Distinzioni e differenze. Spesso la “verità” si riduce a essere un accordo di tante piccole “fake news”, risultato di mediazioni che cristallizandosi formano una massa, come dicevo poc’anzi, un groviglio, una matassa all’interno della quale risulta essere sempre molto difficile orientarsi, trovare il filo, l'”ubi consistam”, l’inizio. Come procedere allora? Come sciogliere i nodi della matassa? Ma i nodi comunque, per quanto”ostili” al raggiungimento di una onesta trasparenza, fanno parte del sistema: possiamo scioglierli? Possiamo ricostruire e ricondurre il filo nel giusto verso?
Da una parte entra in gioco l’educazione nel senso di trarre fuori, di pensare e di riflettere intorno a tutto quello che ci passa per la testa, perchè troppo spesso i nostri pensieri sono condizionati dalla posizione in cui ci troviamo, ovverosia , ad esempio, se mi trovo in uno stato di rabbia è ovvio che i miei pensieri siano determinati dal mio stato emotivo. Di conseguenza devo cercare di governare i miei impulsi per poter riflettere e prendere in considerazione ciò che può essere un pensiero che mantenga lucidità e per vedere meglio ciò che mi circonda. Si tratta tutto sommato di imparare a guardare, mettendo tra parentesi la propria emotività, e di superare anche le nostre barriere ideologiche che vedono cose che non ci sono. Trasparenza e lucidità ci permettono di cogliere ciò che è autentico e ciò che non lo é? Possiamo davvero individuare le differenze? Sì e no. E’ necessario operare un’indagine, una ricerca che richiede tempo e riflessione. Nell’epoca in cui viviamo, tutto ciò non sembra più possibile perchè il tempo è ormai dominato dalla produzione e dalla tecnica. Bisogna fidarsi del proprio istinto, da intendersi come intuizione, e procedere con cautela per arrischiarsi a creare una forma che possa tradurre la realtà e quindi la verità, per avvicinarsi all’autentico. Siamo in grado di distinguere così nettamente ciò che è autentico da ciò che non lo è? Qui entra in gioco la decisione. E la decisione è figlia di che cosa? Non è forse figlia appunto del nostro istinto e quindi della nostra intuizione? L’intuizione è una risorsa che abbiamo accumulato nel tempo e che ci permette di cogliere nell’immediatezza ciò che è di nostro gusto. In altri termini la nostra decisione sembrerrebbe già orientata dalla nostra esperienza, dal nostro sè, in quanto corpo, memoria di esperienze da cui abbiamo tratto un nostro profondo spirito di verità. É una verità soggettiva ma il percorso è eguale per tutti e quindi ha un suo valore in sè e per sè.
Quindi, che cosa possiamo decidere? Decidere significa prendere una posizione. Prendere posizione a partire da dove? Da quella verità che abbiamo fatta nostra e che comunque ha bisogno di un continuo confronto e apertura al dialogo. Da qui nasce l’autorevolezza e la forza di affermare, senza paura di metterla in discussione, la propria verità. Credo che attraverso l’intuizione immediata, spogliati dai nostri pre-giudizi, in purezza, possiamo cogliere una fragranza e una gioia di quel frammento di verità, pur sapendo, per onestà intellettuale, che siamo in divenire. Solo così possiamo vivere fino in fondo la vita ed è per questo che vogliamo resistere a tutto ciò che risulta tecnicamente e proditoriamente prefabbricato in quanto avvelena la dimensione dell’autenticità, certo anche nella forma del mito o dell’ombra di sè, e in quanto perversamente ci sposta verso una dimensione della tecnicizzazione del dato di fatto che persegue obiettivi facili e immediati, scorciatoie per il tutto e subito. Perdendo di vista l’orizzonte di riferimento di cui si carica l’esercizio spirituale che dialoga con il mondo.
Your Content Goes Here

