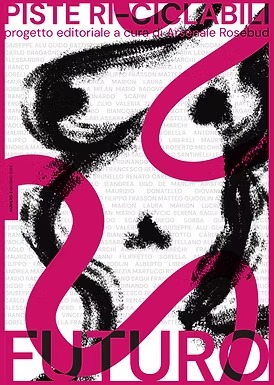
Futuro
La legge pratica ed il tempo futuro
di Antonio Sansone
1. Non intendo scrivere un articolo storiografico sull’etica kantiana. Troppo vasto sarebbe l’argomento che imporrebbe, di conseguenza, un’ indagine critica definita e circoscritta. Il mio intento, invece, è quello di confrontarmi con i problemi teoretici che emergono da alcuni passi della Critica della ragion pratica di Kant. In auseinardersetzung mit Kant und űber Kant mi pongo lo scopo di ragionare sui problemi teoretici che il testo apre in relazione ad un nesso problematico, ancora non adeguatamente sondato, ovvero il rapporto tra le leggi pratiche ( praktische Gesetze ), in particolare quella fondamentale o meglio nota come “imperativo categorico, e il tempo, in modo peculiare l’estasi temporale del futuro.
Sappiamo perfettamente che il fine sia de la Fondazione della metafisica dei costumi del 1785 che della Critica della region pratica del 1788 non quello di definire una teoria morale sic et simpliciter, ma quello di << trovare le condizioni generalissime di possibilità del giudizio morale >>. In analogia con la Critica della ragion pura Kant voleva ragionare sulle condizioni possibilità dell’agire morale e quindi voleva indagare criticamente l’ambito del trascendentale, che resta il vero terreno proficuo sul quale interrogarsi e dal quale ripartire. In effetti, le mie riflessioni si concentreranno proprio sulle condizioni di possibilità della << legge pratica >> in relazione al tempo.
2. Le leggi pratiche sono dei comandi oggettivi che ordinano alla volontà di agire in un certo modo. I comandi hanno senso perché c’è una volontà che può eseguirli, ma può anche non eseguirli. Inoltre le leggi pratiche, quindi, hanno senso nel mondo umano, non in quello animale, e quindi implicano la libertà o meno di agire. Non avrebbe senso la legge se noi non fossimo nella condizione di agire e se noi non fossimo nella condizione di decidere e scegliere come agire. Ne consegue che la legge è immediatamente e necessariamente in relazione con la libertà di agire e la volontà o facoltà di desiderare, come la chiama Kant. In Krp libro I, cap. I Kant sviluppa i nessi fondativi, strutturali dell’ agire, ovvero studia le condizioni di possibilità dell’agire e della legge pratica.
Si può agire in modo condizionato in vista di un fine oggettivo da raggiungere e tale modo di agire implica delle leggi pratiche, sia pure condizionate dalle situazioni contingenti dell’agire. In questo caso il nostro agire e determinato da condizioni sensibili e quindi i comandi saranno ipotetici; c’è un altro comando possibile, che possiamo sperimentare, il quale non è condizionato da situazioni materiali contingenti e determinate, sia pure oggettive. Tale comando o imperativo Kant lo chiama categorico.
In FmC Kant si faceva una domanda: << Come sono possibili tutti questi imperativi ? >>. Subito dopo, in riferimento alla legge morale fondamentale, ovvero all’ imperativo categorico, si chiedeva come sia possibile quest’ultimo, ovvero quali siano le sue condizioni di possibilità.
Ebbene, io vorrei discutere in un confronto con il testo kantiano le implicazioni che quella particolare legge morale, che Kant chiama la Grundgesetz, ovvero l’imperativo categorico, ha in rapporto alle sue condizioni di possibilità. Parlare in Kant di condizioni di possibilità significa entrare a tutto tondo nella questione del trascendentale, che è la chiave di lettura del suo pensiero.
L’ imperativo categorico ( Der kategorische Imperativ ) è << la legge pratica >> ed è prodotto dalla ragion pura, nel senso che quest’ultima mostra le strutture formali del comando che non sono condizionate dalla sensibilità, non hanno un contenuto e proprio per questo rigorosamente a priori.
Scrive Kant: << La ragion pura è per sé sola pratica e dà una legge universale che noi chiamiamo legge morale >>. Qui l’autore vuole dirci che noi possiamo sperimentare come l’attività produttiva, trascendentale a priori, della ragione pura, non empirica, sia immediatamente in grado di strutturare formalmente la realtà. La sua forma produttiva è data ed attiva nella prassi e ciò che la ragione pura produce è di per sé pratico, essendo prodotto in modo incondizionato. La ragione pura mostra nella formulazione del comando << die Form und das Prinzip >> a cui la nostra volontà deve conformarsi, perché la ragione pura è in grado di portare alla luce una struttura formale necessaria, liberandola dai condizionamenti della situazione contingente. Kant è molto chiaro in questo passaggio. Si pone una questione importante: qual è la condizione di possibilità che consente alla ragion pura di produrre un comando << unbedingt >>, incondizionato?
La ragion pura nella produzione dell’imperativo categorico sperimenta la possibilità dell’incondizionatezza che diventa necessità del comando realizzato. Emancipandosi dai vincoli della sensibilità, la ragion pura pratica mostra che l’incondizionatezza del comando è possibile perché la ragion pura è libera di comandare. Quindi la libertà, come ambito impossibile da conoscere e sperimentare, si manifesta in un certo qual modo nella legge morale. Sperimentiamo la libertà come condizione trascendentale dell’agire, << l’unico fatto ( Faktum ) della ragion pura >>.
Senza entrare nel rapporto tra legge pratica, libertà e facoltà del desiderare o volontà, non essendo il focus della mia riflessione, voglio, invece, concentrarmi sul problema del tempo che la legge morale implicitamente o esplicitamente pone in sede teoretica.
3. Poiché la ragione pura è << Gesetzgebung >>, ovvero è in grado di darsi da sé una legge oggettiva ed universale, è evidente che la legge pratica nasce da un fondo ( Grund ) senza fondo, ovvero un abisso ( Abgrund ) che è la condizione originaria-trascendentale in cui è possibile l’atto-azione di porre la legge. Poiché << si può astrarre dalla causalità ( come appartenente al mondo sensibile ) per avere queste leggi pure >>, la possibilità originaria è l’In-differenziato da cui emerge la legge come evento strutturato. La legge accade come Ereignis in una Lichtung originaria che fa da sfondo in cui opera in modo trascendentale la ragione pura. La libertà è quindi l’abisso originario come condizione perché la legge pratica possa accedere e perché accadi in quanto imperativo categorico. La legge morale accade nella sua formulazione universale e necessaria e qui si pone un grande problema teoretico: com’è possibile che nell’ambito originario-trascendentale della libertà als Ab-Grund accada necessariamente la struttura formale della legge pratica che di fatto si esplica nella forma del “tu devi”? Evidentemente la ratio essendi della legge morale è la libertà che coincide perfettamente con la necessità. Solo una condizione di possibilità contemporaneamente libera e necessaria rende possibile alla ragion pura la formulazione della legge pratica. La condizione formale dell’imperativo è infatti libera ma necessaria nella formulazione formale della legge. Se la legge non fosse necessaria, non potrebbe comandare e verrebbe meno in senso costitutivo della legge, ma la condizione della sua imperatività è la necessità. Tuttavia, proprio la struttura formale, universale e necessaria della legge morale apre alla possibilità della scelta possibile e dell’esercizio del libero arbitrio. Che ne è del tempo in questo discorso?
4. Andiamo alla formulazione kantiana della Grundgesetz: << Opera in modo che la massima della tua volontà possa sempre ( jederzeit ) valere in ogni tempo (zugleich ) come principio di una legislazione universale >>.
La formulazione della legge morale pone dei problemi interessantissimi in relazione alla condizione di possibilità dell’imperativo medesimo. Intanto, occorre assolutamente porre l’attenzione alla sottolineatura temporale operata da Kant. Egli accosta due avverbi temporali nella formulazione della Legge fondamentale, come a voler dire il comando deve estendere la sua capacità di accadimento in un arco temporale al contempo non definito e insieme definito. Infatti l’avverbio << jederzeit >> indica un’apertura temporale non definita, mentre << zugleich >> indica il qui ed ora dell’ accadere: la volontà individuale può realmente, qui ed ora, tendere a conformarsi alla Legge universale, mentre quest’ultima può accadere nell’agire individuale, trovandosi insieme e nello stesso tempo.
Perché la massima, che è un principio pratico soggettivo, attraverso la volontà ( La volontà agisce! ) possa tendere a realizzare la Legge nell’agire pratico e tenda sempre di più a conformarsi alla struttura universale della medesima, qual è la condizione di possibilità indispensabile?
Il comando apre implicitamente non solo alla ratio essendi della legge pratica, come abbiamo già visto, alla condizione a priori, ma pone ulteriori interrogativi teoretici: se la legge è accadimento nel mondo sensibile, irruzione produttiva nel mondo sensibile hic et nunc , qual è la condizione che rende possibile l’accadimento della legge nel tempo in avanti, nell’ estasi temporale dello jederzeit? Se la ratio essendi della legge morale è nell’estasi temporale trascendentale del prima, come potrà l’imperativo accadere nel mondo sensibile, poiché irrompe certo nel qui e ora, ma è destinato per struttura necessaria ad aprirsi in ogni tempo e quindi anche nel futuro? Infatti, Kant in un passo della FmC scrive: << Tutti gli imperativi sono espressi dal verbo Sollen […] >> e quindi sono aperti al tempo che verrà, poiché per struttura ontologica il dover essere rinvia alla condizione di possibilità di ciò che è di là da venire.
Kant ci ha posto di fronte ad un grande pròblema: la legge morale accade qui e ora ma comanda alla volontà di conformasi ad essa in una tensione che si proietta nel futuro e non solo nel presente. Infatti, la legge morale mira a costruire un’ umanità nuova, un << Reich der Zwecke >> ( Regno dei fini ) e perché tale regno si costruisca è necessaria una nuova condizione di possibilità che non sia già data, ma sia da venire, ovvero sia originariamente preparata nell’avvenire, cioè nel futuro. Detto in altri termini, se non ci fosse un’originaria, trascendentale condizione di possibilità aperta nel futuro, il dover essere, il Sollen, proprio della Legge morale, non potrebbe accadere. Ma la dicitura incondizionata della Legge esiste, si dà ( es gibt ), quindi è necessario pensare alla condizione di possibilità che apra l’accadimento. Potremmo dire, altresì, che ci deve essere un’apertura, che accade dal futuro, in forza della quale la legge morale può accadere in direzione del futuro. Proprio l’ apertura originaria che viene dal futuro consente quindi l’ apertura del qui ed ora, in virtù della quale possono accadere anche le singole scelte morali e si può esercitare la singola scelta. Il futuro apre il presente nella possibilità che si dà al soggetto di agire nella sua finitudine. La condizione di possibilità del futuro si pone allora come senso temporale originario nel quale può accadere il dono del libero arbitrio che si può, dunque, esercitare in forza della finitudine umana che la struttura trascendentale aperta del tempo-futuro rende possibile.
Infatti, la Legge comanda attraverso il “tu devi” e comanda nel tempo presente alla volontà ( handle ). Quindi il comando irrompe da una condizione senza tempo nel tempo. È un’ irruzione estatica della Legge senza tempo, formale ed universale, nel ambito del sensibile aprendo una paradossalità, poiché la legge noumenica ha luogo nel mondo fenomenico.
Tuttavia, la Legge, che cui la massima può dare ascolto, mostra il suo jederzeit << per il passato, non meno che per il presente e il futuro >>. Pertanto, il presente della legge morale << resta sempre aperto al futuro, poiché dal futuro ha la sua “verità”: dall’ ascolto. […] il dovere morale non è mai, perché sempre “deve”. […] La legge non è, deve: deve sempre ancora comandare, sempre ancora avere ascolto, obbedienza >>.
La legge morale è tale proprio perché nel presente apre ad un dovere che è sempre di la da venire, nel senso che non si compie mai nell’ hic et nunc. Da qui si comprende la ragione per la quale la virtù della legge non si esaurisce mai nel Diritto, che invece realizza leggi nel qui e nell’ora in relazione alla legge, di per sé inesauribile. Il bene, dunque, è un’ attività che si va facendo sempre in un’ apertura teleologica, di la da venire, ovvero in una direzione futura.
La legge è produttiva e performativa, poiché comanda alla volontà, che in autonomia può obbedire o non obbedire. Il dovere della legge fonda il poter essere della legge medesima.
5. Detto ciò, si pone un’ulteriore questione: se c’è come c’è uno scarto ontologico-temporale tra l’ essere come qui ed ora ed il dover essere, come di là da venire, qual è la condizione di possibilità del dover essere ( Sollen ) medesimo della legge? Se la legge apre al futuro in quanto dovere, qual è la condizione di possibilità a priori del suo orientarsi oltre lo jetztzeit? Se c’è la teleologicità della legge, qual è la sua condizione trascendentale a priori?
Se la legge morale als Sollen è rivolta al futuro e non all’essere, in cui si situano le singole leggi positive, proprie del diritto positivo, è chiaro che essa non può essere presente che accade nel presente. Se la legge fosse solo presente, come potrebbe comandare, visto che il comando strutturalmente è rivolto al futuro? Come potrebbe la legge passare dall’ora al non ancora? Sarebbe come passare dall’ essere al non essere ancora, il che è contraddittorio ed impossibile.
Perché ci possa essere il comando e perché il comando sia nella condizione di possibilità di essere tale, ovvero orientato già in avanti, è necessario che ciò che è trascendentalmente avanti, ovvero dopo, sia quella condizione di possibilità perché ci sia il tendere teleologico della legge. Quindi, il futuro è già quell’ apertura originaria che struttura a priori in senso trascendentale la legge.
Ciò detto, solo l’unità del tempo che si apre a partire dal futuro e solo dal futuro può essere la condizione di possibilità della legge morale perché essa << jederzeit zugleich […] gelten kőnne >>.
Il tempo come apertura del futuro verso passato del presente è il senso trascendentale della legge, poiché c’è già una condizione temporale che “corre in avanti”, rendendo possibile il comando dell’imperativo. Allora tutte le leggi positive, in quanto comandi, pur agendo hic et nunc trovano la loro condizione di possibilità in una struttura temporale che è un correre-in-avanti, ovvero un vor-laufen. A questo punto è illuminante un’analogia con quanto Heidegger nei primi anni venti del Novecento va pensando sul rapporto tra temporalità ed esserci. Scrive Heidegger: << L’ esserci è autenticamente presso sé stesso, è davvero esistente, se si mantiene in questo precorrere ( vor-laufen ). Questo precorrere non è nient’altro che il futuro unico e autentico del proprio esserci. Nel precorrere l’esserci è il suo futuro, in modo da ritornare, in questo essere futuro nel suo passato e nel suo presente >>. Come il Dasein è temporalità originaria, così la legge è temporalità originaria nella sua forma pura a priori.

