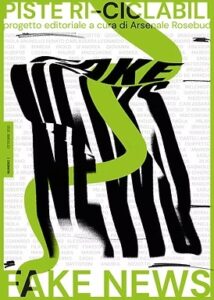
Fake news
Vaccinarsi contro le fake news
di Renato Carlassara
Premessa
Questo primo numero della rivista Piste ri-cliclabili tratta delle Fake News, un argomento ormai onnipresente a diversi livelli nei contesti più disparati. Si potrebbe persino considerare un argomento inflazionato, abusato, eppure capire di cosa si tratta quando si parla di notizie false assume un carattere di urgenza, se non altro perché coinvolge direttamente la nostra vita, quella vera – appunto – nel momento in cui siamo chiamati alle urne per un’elezione, quando dobbiamo decidere se indossare una mascherina o incontrare i nostri amici o anche semplicemente se ci capita di ascoltare un notiziario, leggere un giornale, esprimere un’opinione.
Ci inoltreremo nel vero e proprio labirinto che si apre alla nostra esperienza quotidiana senza pretendere di possedere il filo di Arianna necessario per poi uscirne con la soluzione. Esporremo opinione nostre, ne ascolteremo altrui, racconteremo di fatti ed eventi presenti e passati e forse ci lasceremo anche tentare da una qualche formulazione teorica. Quello che cercheremo di non fare è di insegnare una “verità”, di partire da un presupposto ideologico, di informare sulla natura degli eventi.
Introduzione – Vaccinarsi contro le false notizie
Non è certamente questa la sede per una dissertazione teorica sulla dialettica Vero-Falso, che attraversa la speculazione filosofica fin dai suoi albori. Tuttavia l’enormità dell’argomento non ci può esimere dal delineare un orizzonte di senso entro il quale muovere il nostro sguardo. Il panorama che si dispiega ai nostri occhi è popolato di fenomeni che talvolta manifestano, talaltra sottendono, ma più spesso forse nascondono delle verità. La Verità, infatti, può vivere in un mondo suo, senza alcuna necessità, né tanto meno alcun obbligo di rivelarsi. Se consideriamo, ad esempio, il mondo dei fenomeni naturali, ci troviamo di fronte a una molteplicità di casi dietro ai quali si nascondono verità che sarebbe compito dell’indagine scientifica o, se vogliamo, della speculazione filosofica portare alla luce, per arrivare quindi a una molteplicità di verità che poi si cerca inevitabilmente di unificare, in modo da pervenire alla formulazione di verità di portata più ampia. In questo risiede il valore delle grandi sintesi filosofiche così come della incessante ricerca orientata all’unificazione delle grandezze che sovrintendono le scienze esatte.
Nondimeno la meditazione teologico-religiosa dovrebbe condurre al disvelamento di una Verità unica e trascendente da cui tutte le verità fenomeniche discendono. Ma la meditazione religiosa mostra di ambire ad un livello speculativo molto più sofisticato nel momento in cui ammette il mistero, cioè accetta di convivere con una Verità ultima che sicuramente esiste ma che le facoltà ordinatrici dell’intelletto umano si dimostrano insufficienti a comprendere. Fino a questo punto la questione sembra abbastanza semplice e così diventa più interessante considerare le conseguenze che derivano da questa scomoda convivenza con un Ente misterioso. I teologi perdoneranno la sintesi brutale, ma sostanzialmente ci si trova di fronte a due tipi di atteggiamento che tuttavia solo apparentemente configurano un bivio da cui si diramano vie diverse. Una possibilità sarebbe data dall’accettazione per fede dell’esistenza di questo Ente superiore. Una fede però, attenzione, che l’essere umano non può conquistare autonomamente attraverso una volitiva azione del proprio libero arbitrio. No! L’atto di fede può solo promanare da quello stesso Ente superiore, come estremo ed assoluto dono d’amore. È evidente che la straordinaria forza di questa concezione teleologica risiede proprio nella sua tautologia.
Un’altra concezione non meno interessante e pregnante considera la possibilità di indagare questa Verità ultima, conoscibile in virtù di un processo spirituale iniziatico che permette all’essere umano di accoglierla. Anche in questo caso però, Essa discende da sé, annullando ogni potere conoscitivo dell’intelletto umano. Si tratterebbe pertanto di una Verità in sé conchiusa, totalmente autoreferenziale e quindi anche in questo caso tautologica, dal momento che non solo essa è fonte e origine di sé stessa, ma anche destinata a rimanere in sé stessa giacché diventa incomunicabile, o meglio, ammettendone la trasmissibilità, impone, per essere compresa, lo stesso percorso spirituale, la stessa illuminazione che costituisce il grande dono dell’iniziato all’iniziato. Fermo restando che, a questo punto, il dialogo fra iniziati non richiede comunicazione né si prefigge la trasmissione o l’accoglimento di una Verità che è già risolta e presente di per sé, togliendo ogni residuo valore a qualsiasi tensione conoscitiva.
Torniamo al nostro sublime panorama fenomenologico.
Nel mondo dei fenomeni si nascondono anche falsità, menzogne, che sono limitate all’agire umano, anche se non necessariamente lo caratterizzano, instaurando un complesso rapporto di convivenza con le verità. Secondo uno dei cardini della logica classica il Falso non sarebbe altro che la negazione del Vero, come se Vero e Falso fossero le due facce di una stessa medaglia che non possono essere separate, al punto che uno è in grado di definire l’altro.
Tuttavia la logica classica sembra trascurare (o vuole trascurare) il carattere eminentemente ed esclusivamente umano della categoria Falso, che non necessariamente appartiene alla categoria Vero. Da questa prospettiva Vero e Falso sono ontologicamente diversi.
Se una verità può vivere in un mondo suo, svincolata dalla necessità di calarsi nel mondo fenomenico, una falsità, al contrario, deve incarnarsi in un fenomeno. Una falsità che rimanesse in una condizione di assoluta potenzialità, che non si materializzasse in un fenomeno del nostro mondo umano, perderebbe di senso.
La falsità, come prodotto dell’agire o del pensiero umano, lancia una sfida all’uomo stesso perché compromette il suo rapporto con le cose del mondo. Secondo grandi scuole di pensiero, fra le quali si possono annoverare anche i sacri testi delle grandi religioni, l’uomo instaura un rapporto con le cose del mondo attraverso i nomi, vale a dire attraverso il linguaggio. Il principio confuciano della “rettificazione dei nomi” è in questo senso forse la più alta e consapevole, anche se non l’unica, riflessione sul rapporto fra l’uomo e le cose del mondo, che si configura a tutti gli effetti come un rapporto politico fra l’uomo e la verità sulle cose.
La falsità come prodotto dell’agire o del pensiero umano, solo attraverso il linguaggio può trovare l’incarnazione necessaria alla sua permanenza nel mondo e imperativo etico dell’uomo diventa lo smascheramento di quella falsità. Per riaffermare il proprio retto rapporto con le cose, per rivendicare la propria giusta collocazione nel mondo, l’uomo è obbligato a smascherare la falsità nel momento stesso in cui essa si incarna assumendo le sembianze di una verità. Il Falso pretende di essere disvelato laddove il Vero può rimanere celato.
La falsità, oltre ad incarnarsi, manifesta la necessità di rivolgersi a qualcuno che la accolga come verità. Se così non fosse il suo processo di materializzazione sarebbe fatalmente incompleto. La falsità pretende di essere comunicata e questo può avvenire attraverso diversi canali linguistici, diversi codici, variabili a seconda degli ambiti tematici, storici, sociali, antropologici, ecc. in cui si cala. Per esempio, a seconda delle epoche storiche, le false verità si sono servite dello strumento epistolare, cronachistico, in seguito anche a stampa, quindi giornalistico, radio-televisivo, informatico…
Qualunque forma di comunicazione trasmette o quanto meno sottende contenuti. L’accertamento della verità apparentemente coincide con la verifica dell’attendibilità dei contenuti della comunicazione. Tuttavia l’esperienza insegna che la verifica della veridicità – o della correttezza – di una comunicazione umana non può basarsi unicamente sull’analisi dei dati oggetto di trasmissione. L’accesso ai dati è difficile, talvolta impossibile, per lo più appannaggio di pochi individui considerati “esperti”. L’esperienza insegna che in relazione ad uno stesso fenomeno gli “esperti” raramente propongono gli stessi dati e ancor più raramente concordano sulla loro interpretazione. Quindi risulta pressoché impossibile accertare la veridicità di una comunicazione basandosi sui dati trasmessi, a meno di accettare il principio di “verità in fiducia”, per cui si accettano i dati così come vengono trasmessi e interpretati da qualcuno di cui “ci si fida”.
Il non-esperto, quindi, sembra condannato a convivere con assunti contraddittori senza poter accertare la loro sostanziale verità o falsità. Non solo. Da un punto di vista etico, il rapporto che si instaura con la dinamica Vero-Falso, qualunque esso sia, obbliga ad un continuo ripensamento della collocazione del Falso nel paesaggio umano: ad esempio si dovrà considerare lo stadio intermedio del “verosimile”, oppure ci si accorgerà che il Falso assume spesso un carattere eversivo rispetto ad un ordine costituito non necessariamente giusto dal punto di vista etico.
Il problema si è spostato. La necessità di verificare la veridicità di un assunto in base alla sola analisi dei dati forniti, oltre a rivelarsi quasi impossibile, non appare più così cogente.
Qualunque pretesa di verità, così come qualsiasi tentativo di smascherare una falsità si scontra inevitabilmente con possibili argomentazioni contrarie alimentando la interminabile dialettica Vero-Falso. Inutile è il ricorso alla presunta oggettività dei dati. Il puro dato oggettivo, ammesso che esista, vive in una dimensione estranea al paesaggio umano e solo le scienze esatte possono faticosamente tentare di accostarsi a quella dimensione. Nel momento in cui il dato oggettivo si cala nel mondo umano entra inevitabilmente nella sfera politica che quel mondo caratterizza, giustificando opposte interpretazioni.
A livello individuale l’interpretazione che si può dare di un dato può dipendere dai fattori più disparati: abitudini, convinzioni, cultura personale, gusto… Il confluire di diverse individualità in una stessa interpretazione assume una dimensione ideologica al punto che quella interpretazione del dato di realtà può diventare una vera e propria bandiera per un gruppo che si considera allineato rispetto a quella “verità”. Qualunque tentativo di affermare una verità, pertanto, genera ideologia, così come, specularmente, il tentativo di smascherare una falsità.
Il fenomeno delle Fake News si basa proprio su questa dinamica, destinata ad autoalimentarsi, in un circolo che si può considerare, a seconda dei punti di vista, virtuoso o vizioso.
L’unica via per uscire da un processo dialettico che non può arrivare ad alcuna conclusione consiste nel concentrare l’attenzione sul processo logico che ha prodotto quell’assunto, che si configura come il punto di arrivo di un percorso che trova la sua ragion d’essere nel contesto stesso che ha prodotto quel messaggio. Come sosteneva Wittgenstein, “se vuoi conoscere il contenuto di un teorema, considera ciò che la dimostrazione dimostra”. Vale a dire che il contenuto del messaggio riceve senso dal percorso logico che conduce alla formulazione finale. Il messaggio, l’assunto, l’interpretazione del dato di realtà non viene concepito come qualcosa di statico, come un dogma o come uno slogan, ma gli viene restituito il suo carattere dinamico e multiforme. Questo percorso dinamico corrisponde alla logica che sottende il processo di appaesamento del dato oggettivo nel mondo delle cose umane attraverso il linguaggio. È attraverso il linguaggio che gli esseri umani stabiliscono un rapporto con la realtà delle cose. Ma il linguaggio è qualcosa di variabile, qualcosa che riceve una forma adottando delle regole condivise, una sintassi condivisa nell’ambiente da cui il messaggio stesso proviene e a cui il messaggio è destinato, dei quali è la incancellabile marca rivelatrice.
Se ci interroghiamo sulla veridicità o falsità di un messaggio, se temiamo di trovarci dinanzi ad una temibile fake new o, certi della sua falsità, cerchiamo di smascherarla, inneschiamo quel processo automatico e inarrestabile di contrapposizione fra chi si schiera dalla parte di una “verità” e chi, sostenendo la tesi contraria, rivendica per sé la patente di veritiero e assegna alla fazione avversa quella di bugiardo. Gli effetti di questa perversa quanto inutile diatriba sfiorano il ridicolo – il comico involontario che purtroppo non fa ridere – nel momento in cui si mette in atto la gara di “intelligenza” fra chi “vede più in là”, fra chi è convinto di essere immancabilmente “dalla parte giusta”, fra chi “non ci casca”, fra chi con perspicacia riconosce la falsità anche nella verità più incontestabile.
La pandemica malattia del nostro tempo non è il proliferare di Fake News che necessitano di essere contrastate, ma la mancata “rettificazione dei nomi” che compromette il rapporto che gli esseri umani instaurano con le cose del mondo. L’antidoto va ricercato nella comprensione profonda della struttura logica del messaggio attraverso l’analisi del linguaggio con cui è stato formulato.
L’analisi comparata e simultanea di linguaggio e contenuto considerati inestricabilmente connessi assume a tutti gli effetti un valore estetico che predispone l’essere umano ad una convivenza fondata sulla capacità di collocare correttamente e democraticamente le informazioni contrastanti ognuna nel proprio contesto che, a questo punto, diventa riconoscibile.
È nella contemplazione estetica del valore del messaggio che si trova la via di fuga dal labirintico intrecciarsi di dati e interpretazioni più o meno contrastanti. Non è il filo di Arianna che ci guida verso la soluzione, che ci fornisce la certezza della verità. Tutt’altro. È piuttosto uno sguardo sereno su un mondo in cui si dibattono entità in disaccordo, tutte accomunate da una futile rincorsa verso il dato più significativo, senza accorgersi che si tratta di una corsa senza meta, senza alcun ordine, simile allo sbattere di mosche impazzite contro le pareti del vaso in cui sono state imprigionate.
Concludo con un invito di Kakuzo Okakura:
«Il cielo dell’umanità moderna si è realmente frantumato nella lotta titanica per la ricchezza e il potere. Il mondo brancola nelle tenebre dell’egoismo e della volgarità. La conoscenza si compra a prezzo della cattiva coscienza, la generosità si pratica a fini utilitaristici.
Abbiamo nuovamente bisogno di una Niuka che ponga rimedio alla completa devastazione; attendiamo il grande avatāra. Beviamo, nel frattempo, un sorso di tè. Lo splendore del meriggio illumina i bambù, le sorgenti gorgogliano lietamente e nella nostra teiera risuona il mormorio dei pini. Abbandoniamoci al sogno dell’effimero, lasciandoci trasportare dalla meravigliosa insensatezza delle cose».

